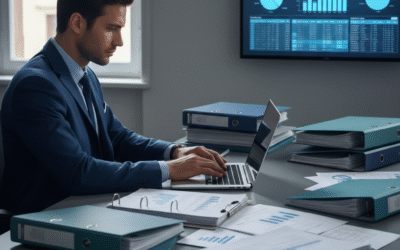La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27238/2025 depositata l’11 ottobre, chiarisce in modo netto che il diritto alla detrazione Iva non può essere subordinato alla prova del pagamento della fattura. A contare, per il giudice di legittimità, sono solo due elementi: l’effettiva esecuzione dell’operazione e il possesso di una fattura valida, regolarmente annotata. Tutto il resto – inclusa la dimostrazione del flusso finanziario – è un requisito “aggiuntivo” che il legislatore nazionale non può pretendere senza tradire il principio di neutralità dell’imposta armonizzata.
1
|
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast. |
1
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La Cassazione (ord. n. 27238/2025) esclude che la prova del pagamento sia condizione per la detrazione Iva.
- Servono due soli requisiti: operazione effettiva (cessione/prestazione reale) e fattura valida annotata nei registri Iva.
- Richiedere la dimostrazione del pagamento introduce un “terzo requisito” non previsto dalla direttiva 2006/112/CE né dal dpr 633/1972.
- La giurisprudenza Ue (ad es. causa C-152/02) tutela il principio di neutralità dell’Iva e limita il formalismo nazionale.
- L’Agenzia delle entrate, con risposta 175/2022, ha già riconosciuto che il mancato pagamento non incide di per sé sul diritto alla detrazione.
- I contribuenti devono conservare documentazione idonea a provare l’effettività delle operazioni, più che il mero flusso finanziario.
- In presenza di operazioni inesistenti o fraudolente, la detrazione resta comunque negata: la pronuncia non copre i casi di abuso.
1
Il caso deciso con l’ordinanza n. 27238/2025
La vicenda nasce in Calabria e riguarda una liquidazione automatizzata operata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del dpr 633/1972, per Iva relativa al periodo d’imposta 2012. L’Ufficio, nella fase di controllo, nega alla contribuente il diritto alla detrazione dell’imposta esposta in alcune fatture d’acquisto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado condivide la posizione dell’Agenzia delle entrate e conferma l’atto. La motivazione ruota attorno a un punto molto preciso: secondo il giudice regionale, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo l’esistenza delle fatture e la loro corretta registrazione, ma anche l’effettivo pagamento dei relativi importi, documentando la provvista degli assegni circolari indicati dal fornitore e la relativa movimentazione bancaria.
La contribuente, però, in giudizio aveva già prodotto i registri Iva, le fatture e una dichiarazione del fornitore che attestava l’avvenuto pagamento tramite assegni circolari identificati per numero. Per i giudici di merito questo non basta: mancherebbe la prova della copertura degli assegni e della loro emissione, e quindi il credito Iva non potrebbe considerarsi provato.
È proprio questo passaggio logico – la pretesa di un quid pluris probatorio legato al pagamento – che la Cassazione giudica non conforme al quadro unionale e interno in materia di detrazione.
Il quadro UE: neutralità e meccanismo della detrazione
Nel ricostruire la vicenda, la Cassazione parte dal livello sovranazionale. L’Iva è un’imposta armonizzata, regolata dalla direttiva 2006/112/CE, la cosiddetta direttiva rifusione. L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l’imposta deve gravare in modo definitivo solo sul consumatore finale, mentre per i soggetti passivi il meccanismo della detrazione garantisce la neutralità lungo l’intera catena delle operazioni.
Gli articoli 167 e seguenti, e in particolare l’articolo 168, fissano i principi cardine: il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e spetta nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati per operazioni soggette a imposta. La prova del pagamento, come si vede, non entra nella struttura del diritto, che si fonda su due assi: da un lato l’esigibilità dell’imposta, dall’altro l’utilizzo del bene o servizio in operazioni imponibili.
Sul piano interno, questi principi vengono recepiti dagli articoli 19 e seguenti del dpr 633/1972. L’articolo 19 utilizza una formulazione sostanzialmente coincidente a quella della direttiva: il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile. Di nuovo, nessun riferimento alla necessità di dimostrare l’avvenuto pagamento della fattura come condizione per esercitare il diritto.
Due soli requisiti per la detrazione, non la prova del pagamento
La Corte di cassazione, muovendo da questo quadro normativo, ricostruisce in termini sintetici – ma molto rigidi – quali siano le condizioni che devono verificarsi perché la detrazione Iva sia legittima.
Da una parte c’è un requisito sostanziale: l’operazione imponibile deve essersi effettivamente realizzata. Questo vuol dire che la cessione di beni o la prestazione di servizi devono essere reali, non fittizie, con un effettivo trasferimento o una prestazione resa.
Dall’altra parte c’è il requisito formale: il soggetto passivo deve possedere una fattura valida (o altro documento equivalente riconosciuto dallo Stato membro) e tale documento deve essere regolarmente annotato nei registri Iva.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, quando questi due presupposti sono dimostrati, il diritto alla detrazione è perfezionato e non può essere condizionato a ulteriori adempimenti. La prova del pagamento della fattura, quindi, non rientra tra le condizioni richieste né dalla direttiva 2006/112/CE né dalla disciplina nazionale che la recepisce. Pretenderla significa introdurre un “terzo requisito” non contemplato dal diritto unionale.
La conseguenza? Una limitazione indebita del diritto alla detrazione, con un vulnus diretto al principio di neutralità dell’imposta, perché l’onere probatorio si sposta su un elemento che non è parte integrante del meccanismo armonizzato.
Detrazione Iva senza pagamento fattura e giurisprudenza Ue
La posizione della Cassazione non nasce nel vuoto. Il Collegio richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che più volte ha ribadito un’impostazione sostanzialista in tema di detrazione.
In particolare, viene richiamata la pronuncia resa nella causa C-152/02, in cui i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato che gli Stati membri non possono imporre condizioni ulteriori che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione. Il diritto dell’operatore economico, quando l’Iva è dovuta o assolta a monte e sussistono i requisiti sostanziali e formali stabiliti dalla direttiva, non può essere frustrato da formalismi eccedenti.
Dentro questo solco, la detrazione Iva senza pagamento fattura, se l’operazione è reale e la fattura corretta, non è affatto una “forzatura”: è esattamente ciò che la logica neutrale dell’imposta richiede. Laddove il legislatore nazionale – o la prassi applicativa – cerchi di appesantire l’accesso alla detrazione con ulteriori condizioni, il rischio è quello di scivolare in un formalismo incompatibile con il diritto unionale.
Naturalmente resta fermo che, in presenza di operazioni inesistenti o fraudolente, il discorso cambia del tutto: in quei casi il problema non è la mancanza di pagamento, ma l’assenza stessa del presupposto sostanziale dell’operazione.
L’onere della prova e il limite al formalismo fiscale
La Cassazione non nega che, in caso di contestazione, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la detrazione resti in capo al contribuente. Su questo non ci sono deroghe: chi vuole detrarre deve essere in grado di provare sia l’effettività delle operazioni, sia la correttezza formale delle fatture.
Il punto, però, è capire che cosa rientri esattamente in questo onere. Secondo il giudice di legittimità, la richiesta del pagamento documentato – con prova della provvista degli assegni, dei movimenti bancari e via dicendo – esula dai confini del diritto alla detrazione come delineato dalla direttiva 2006/112/CE e dal dpr 633/1972. È un passaggio in più, che finisce per alterare la struttura stessa dell’istituto.
La Corte parla con chiarezza di un “terzo requisito” non previsto sul piano normativo, né giustificato dall’interpretazione della Corte di giustizia. Perciò la sentenza della Corte di merito viene cassata, con rinvio alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la ridefinizione delle spese di lite.
Il messaggio, in filigrana, è piuttosto netto: il formalismo fiscale non può spingersi fino al punto di comprimere il nucleo essenziale del diritto alla detrazione Iva, che resta uno strumento di garanzia e non un premio da concedere solo a chi supera prove probatorie aggiuntive.
Il principio di diritto dettato dalla Cassazione
Per evitare equivoci futuri, la Cassazione formula un vero e proprio principio di diritto. In sintesi, afferma che il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi e dà prova del requisito formale, attraverso una fattura d’acquisto valida e annotata nei registri Iva.
In questo quadro, la prova del pagamento non è richiesta. Non perché sia irrilevante in assoluto – sul piano civilistico, contabile o ai fini di altre verifiche può avere ancora un peso – ma perché non fa parte dei presupposti che condizionano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.
Si tratta di un passaggio che, nella prassi, potrà essere invocato ogni volta che l’amministrazione dovesse pretendere documentazione bancaria come condizione per riconoscere la detrazione su fatture altrimenti regolari e riferite a operazioni dimostrate come effettive. Il confine, però, resta delicato: se il Fisco contesta l’inesistenza dell’operazione, la mancanza di tracciabilità può essere un indizio, ma non può trasformarsi in un presupposto legale autonomo.
Il coordinamento con l’Agenzia delle entrate e l’impatto operativo
Non è la prima volta che il tema viene affrontato. Nella risposta a interpello n. 175/2022, l’Agenzia delle entrate aveva già riconosciuto che il mancato pagamento di una fattura non incide, di per sé, sul diritto alla detrazione dell’Iva in essa indicata. La posizione di prassi, quindi, va nella stessa direzione della giurisprudenza di legittimità, almeno in linea teorica.
Ciò che cambia con l’ordinanza n. 27238/2025 è il livello di formalizzazione del principio e la sua spendibilità nel contenzioso. Là dove gli Uffici, in sede di accertamento o controllo automatizzato, pretendano la prova dell’avvenuto pagamento come condizione decisiva, il contribuente potrà richiamare non solo la direttiva 2006/112/CE e gli articoli 19 e seguenti del dpr 633/1972, ma anche questo arresto della Cassazione.
Sul piano operativo, però, non si può pensare che la detrazione Iva senza pagamento fattura diventi una sorta di via libera a comportamenti disinvolti. Il contribuente resta tenuto a conservare una documentazione robusta, capace di dimostrare: il contratto o l’ordine, l’effettiva consegna dei beni (documenti di trasporto, verbali di consegna) o l’effettiva prestazione di servizi (report, corrispondenza, elaborati).
Si consideri, ad esempio, un’impresa che commissiona una consulenza tecnica articolata: persino in assenza di immediata prova del pagamento, la somma di contratto, report di attività, scambio di e-mail e fattura registrata costituisce un quadro probatorio capace di sostenere il diritto alla detrazione, in linea con quanto affermato dalla Cassazione.