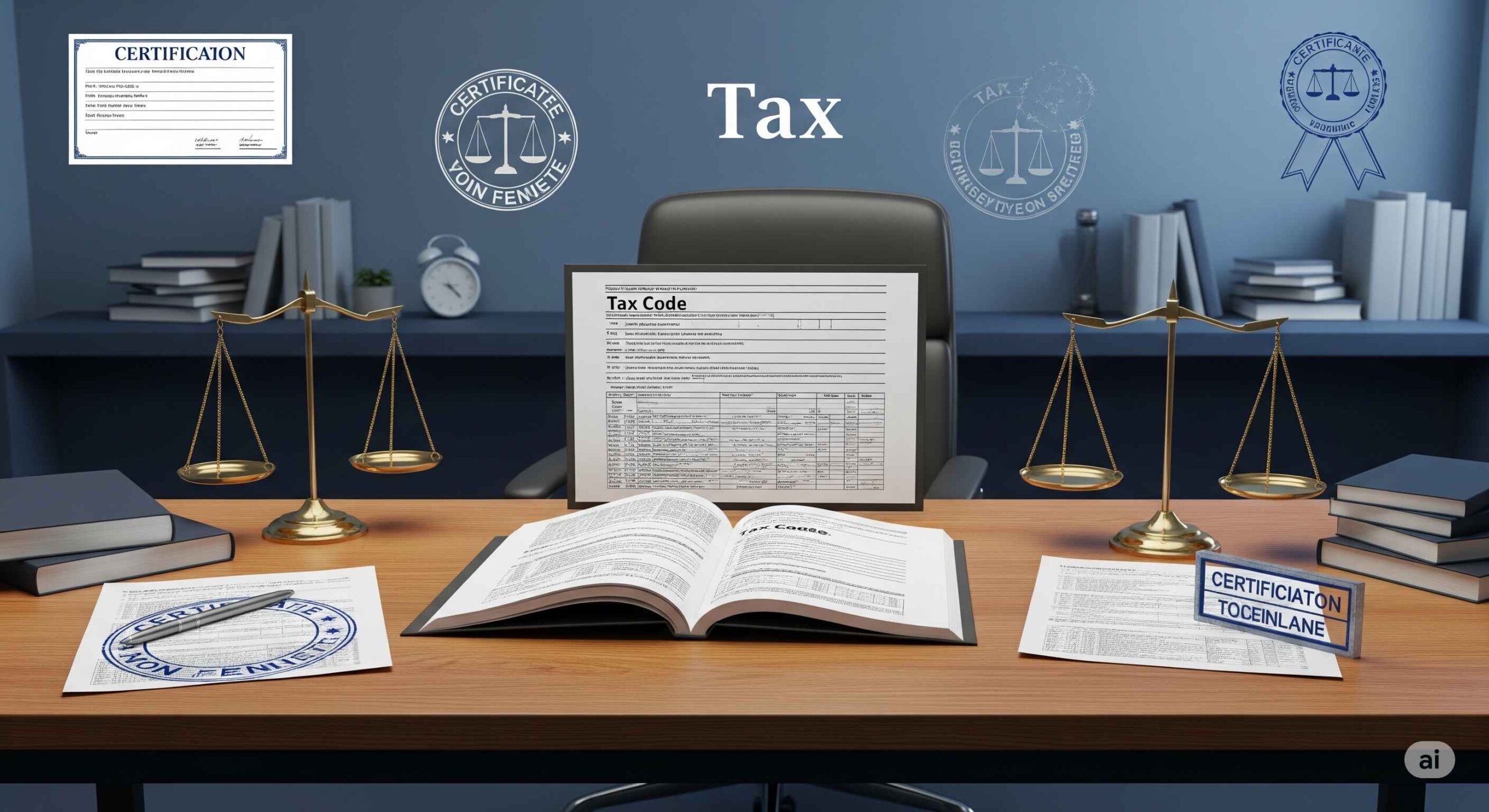L’emanazione dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025 (prot. n. 18), firmato dal viceministro Maurizio Leo e dal direttore generale delle Finanze Giovanni Spalletta, rappresenta un intervento di portata sistemica nella disciplina dei crediti d’imposta. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), con l’obiettivo di fornire criteri interpretativi uniformi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. La genesi del documento ministeriale trova le sue radici nelle criticità interpretative emerse a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale della materia. La Corte di Cassazione, attraverso molteplici pronunce, aveva sviluppato orientamenti non sempre coerenti sulla distinzione tra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, culminando con la sentenza delle Sezioni Unite n. 34419 dell’11 dicembre 2023. Tale scenario di incertezza ermeneutica aveva determinato un approccio disomogeneo da parte degli uffici finanziari, con conseguenti ripercussioni negative tanto sul piano della certezza giuridica quanto su quello dell’efficacia dell’azione amministrativa.
|
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast. |
1
Quadro normativo di riferimento e contesto evolutivo
Il decreto sanzioni (D.Lgs. 24 giugno 2024, n. 87) ha dato attuazione alla delega fiscale contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), numero 5), della legge 9 agosto 2023, n. 111, introducendo per la prima volta una definizione sistematica dei crediti d’imposta inesistenti e non spettanti. La riforma si colloca in un più ampio processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario, ispirato ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.
L’articolo 1, comma 1, lettere g-quater e g-quinquies del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto sanzioni, ha introdotto definizioni normative precise che si applicano tanto in ambito penale quanto in quello delle sanzioni amministrative tributarie. Tale scelta sistematica rappresenta un elemento di novità rispetto al precedente approccio frammentario e spesso contradditorio della giurisprudenza di legittimità.
Definizione e caratteristiche dei crediti inesistenti
Secondo l’articolo 1, comma 1, lettera g-quater del D.Lgs. 74/2000, sono crediti inesistenti:
- I crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- I crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
La prima categoria ricomprende le ipotesi in cui difettano i presupposti costitutivi del credito, come definiti dalle fonti primarie o secondarie della disciplina agevolativa. Il MEF precisa che i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere “specificamente indicati” dalla normativa, escludendo da tale perimetro le fonti di dettaglio non espressamente richiamate, quali manuali tecnici o prassi amministrative prive di specifico rinvio normativo.
La seconda categoria, invece, attiene alle ipotesi di fraudolenza nella rappresentazione dei presupposti del credito. In questo caso, la condotta del contribuente assume connotati di particolare gravità, configurando una violazione qualificata dalla presenza di dolo specifico e dall’utilizzo di artifici o simulazioni.
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la possibilità che i crediti inesistenti possano emergere anche da controlli automatici o formali. Il decreto sanzioni ha eliminato la precedente limitazione che escludeva tale possibilità, ampliando significativamente le facoltà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Disciplina dei crediti non spettanti: casistica e regime applicativo
La definizione di credito non spettante, contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies del D.Lgs. 74/2000, articola tre distinte fattispecie:
Prima categoria: violazioni delle modalità di utilizzo
Rientrano in questa categoria i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento. L’atto di indirizzo ministeriale fornisce esemplificazioni pratiche di particolare interesse:
- Utilizzo di crediti in un arco temporale inferiore a quello previsto dalla legge (ad esempio, utilizzo in un anno anziché in due);
- Superamento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa (c.d. “splafonamento”), con riferimento ai limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o all’articolo 1, comma 153, della legge 31 dicembre 2007, n. 244;
- Utilizzo per l’estinzione di debiti non consentiti dalla normativa specifica (esempio paradigmatico: utilizzo per debiti previdenziali quando la norma lo vieta espressamente).
Seconda categoria: difetto di elementi qualificanti
Questa categoria ricomprende i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento.
Il MEF chiarisce che si tratta di crediti che “difettano di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione”. Tale precisazione assume particolare rilevanza per i crediti d’imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo, dove la qualificazione tecnica degli investimenti costituisce spesso terreno di controversia.
Terza categoria: difetto di adempimenti amministrativi
Sono ricompresi in questa categoria i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. Il regime sanzionatorio prevede tuttavia una distinzione importante: se gli adempimenti amministrativi non erano previsti a pena di decadenza, il contribuente può sanare la violazione entro un anno, riducendo la sanzione a 250 euro (articolo 13, comma 4-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Regime sanzionatorio: principi di proporzionalità e gradualità
La riforma del regime sanzionatorio introdotta dal decreto sanzioni rappresenta un significativo mutamento di paradigma rispetto al precedente impianto normativo. Il nuovo sistema si caratterizza per una maggiore proporzionalità tra violazione e sanzione, introducendo una gradualità che tiene conto della gravità della condotta.
Sanzioni per crediti inesistenti
L’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che l’indebita compensazione di crediti inesistenti è punita con sanzione pari al 70% del credito utilizzato, in luogo della precedente sanzione variabile dal 100% al 200%. Si tratta di una riduzione significativa che testimonia la volontà del legislatore di calibrare la risposta sanzionatoria in modo più equilibrato.
Tuttavia, quando i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, la sanzione è aumentata dalla metà al triplo (articolo 13, comma 5-bis del D.Lgs. 471/1997). In questo caso, la sanzione può raggiungere il 210% del credito utilizzato (70% × 3), configurando un regime particolarmente severo per le condotte connotate da dolo specifico.
Sanzioni per crediti non spettanti
Per i crediti non spettanti, l’articolo 13, comma 4-bis del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione pari al 25% del credito utilizzato, ridotta rispetto al precedente 30%. Il regime si completa con la previsione di cui al comma 4-ter, che stabilisce una sanzione fissa di 250 euro per le violazioni sanabili entro un anno dalla commissione.
Tale distinzione riflette il diverso disvalore delle condotte: mentre i crediti inesistenti presuppongono l’assenza totale o parziale dei requisiti previsti dalla legge, i crediti non spettanti attengono prevalentemente a violazioni delle modalità di utilizzo o a difetti di carattere formale.
Certificazione tecnica: efficacia vincolante e limiti operativi
L’atto di indirizzo ministeriale dedica ampio spazio al ruolo della certificazione tecnica, disciplinata dall’articolo 23 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. La certificazione tecnica assume una funzione centrale nel sistema di tutela del contribuente, configurandosi come uno strumento di compliance preventiva.
Effetti vincolanti della certificazione
Il MEF chiarisce che la certificazione tecnica “esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”. In presenza di una certificazione valida, l’Amministrazione non può contestare i profili tecnico-qualitativi dell’investimento, salvo prova di frode o dolo.
Questa previsione assume particolare rilevanza per i crediti d’imposta relativi ad attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, settori caratterizzati da elevata complessità tecnica e frequenti controversie interpretative.
Limiti e condizioni di efficacia
L’efficacia vincolante della certificazione è subordinata alla sua validità e alla correttezza della rappresentazione dei fatti sottostanti. Il MEF precisa che eventuali contestazioni possono riguardare esclusivamente:
- Aspetti formali o modalità di utilizzo del credito;
- Profili non attinenti all’esistenza sostanziale del credito;
- Ipotesi di frode o dolo nella rappresentazione dei fatti.
È esclusa, invece, la possibilità di contestare la qualificazione tecnica dell’investimento quando sia supportata da certificazione valida rilasciata prima della constatazione di eventuali violazioni.
Autotutela tributaria: principi e modalità applicative
L’atto di indirizzo ministeriale valorizza l’istituto dell’autotutela tributaria come strumento di risoluzione preventiva delle controversie e di razionalizzazione dell’attività di controllo. L’autotutela, disciplinata dall’articolo 287 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 600, si articola in due distinte tipologie:
Autotutela obbligatoria
È prevista per errori manifesti dell’Amministrazione, quali:
- Errori di persona (identificazione del soggetto passivo);
- Errori di calcolo nell’applicazione delle norme tributarie;
- Errori nella qualificazione giuridica del tributo;
- Doppia imposizione per il medesimo presupposto;
- Mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati.
Autotutela facoltativa
È rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione e riguarda:
- Vizi di legittimità dell’atto impositivo;
- Infondatezza della pretesa tributaria;
- Sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali di legittimità;
- Mutamenti della prassi amministrativa.
Il MEF invita gli uffici a valutare attentamente l’esercizio dell’autotutela facoltativa nei casi di atti impositivi che si basano esclusivamente su contestazioni legate alla qualificazione dell’investimento, soprattutto quando il contribuente abbia prodotto certificazione tecnica valida.
Disciplina procedurale: termini e modalità di recupero
Il D.Lgs. 19 gennaio 2024, n. 13, ha introdotto l’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina in modo uniforme il procedimento di recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati. La nuova disciplina si caratterizza per:
Termini di decadenza differenziati
- Crediti non spettanti: recupero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo;
- Crediti inesistenti: recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
La distinzione temporale riflette la diversa gravità delle violazioni: i crediti inesistenti, caratterizzati dall’assenza totale o parziale dei presupposti costitutivi, sono soggetti a un termine più lungo che tiene conto della maggiore complessità accertativa.
Modalità procedurali
L’Agenzia delle Entrate deve emanare apposito atto di recupero da notificare a pena di decadenza entro i termini sopra indicati. L’atto deve contenere:
- Specifica motivazione della contestazione;
- Indicazione delle norme violate;
- Quantificazione del credito da recuperare;
- Calcolo delle sanzioni applicabili;
- Indicazione dei termini e delle modalità per l’eventuale definizione agevolata.
Profili interpretativi e questioni controverse
L’atto di indirizzo ministeriale affronta alcune questioni interpretative di particolare complessità, con specifico riferimento ai crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Fonti normative rilevanti per la qualificazione dei crediti
Il MEF chiarisce che i requisiti oggettivi e soggettivi rilevanti per la qualificazione dei crediti devono essere “specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento”. Sono escluse dal perimetro rilevante:
- Fonti di dettaglio non espressamente richiamate;
- Manuali tecnici privi di specifico rinvio normativo;
- Prassi amministrative non codificate;
- Orientamenti giurisprudenziali di merito.
Disconoscimento per ragioni interpretative
Una questione particolarmente delicata riguarda i crediti d’imposta disconosciuti per ragioni interpretative, fenomeno frequente nel settore della ricerca e sviluppo. Il MEF precisa che tali crediti rientrano nella categoria della “non spettanza” quando difettano di “ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria”.
Questa precisazione potrebbe attenuare la portata della circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2020, n. 31, che aveva prospettato l’inesistenza di crediti relativi a costi che, in base a valutazioni tecniche del MIMIT, non risultavano agevolabili.
Impatti sul contenzioso tributario e prospettive evolutive
L’atto di indirizzo ministeriale è destinato ad avere riflessi significativi sul contenzioso tributario pendente e sulla strategia difensiva dei contribuenti. Le principali implicazioni riguardano:
Controversie in corso
Per le controversie già pendenti, l’orientamento ministeriale può essere invocato come elemento di valutazione dell’infondatezza della pretesa tributaria, particolarmente nei casi in cui:
- Il contribuente abbia prodotto certificazione tecnica valida;
- La contestazione attenga a profili interpretativi non supportati da specifiche previsioni normative;
- L’atto impositivo si basi su valutazioni tecniche successive all’investimento.
Strategie difensive
I contribuenti interessati da controlli sui crediti d’imposta dovrebbero considerare:
- La produzione tempestiva di certificazione tecnica degli investimenti;
- L’invocazione dell’autotutela nei casi di atti impositivi infondati;
- La distinzione tra profili di inesistenza e non spettanza ai fini della strategia processuale;
- L’utilizzo degli strumenti di definizione agevolata previsti dalla normativa.
Considerazioni conclusive e prospettive applicative
L’atto di indirizzo del MEF rappresenta un tentativo di sistematizzazione di una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica e frequenti controversie interpretative. L’efficacia del provvedimento dipenderà dalla sua concreta applicazione da parte degli uffici periferici e dal recepimento da parte della giurisprudenza.
Particolare attenzione meritano i profili di coordinamento tra la nuova disciplina e le disposizioni preesistenti, considerando che la riforma si applica alle violazioni successive al 1° settembre 2024. La coesistenza di due regimi normativi può generare ulteriori complessità applicative, richiedendo un’attenta valutazione caso per caso.
La valorizzazione della certificazione tecnica come strumento di tutela del contribuente rappresenta, infine, un elemento di novità che potrebbe favorire lo sviluppo di un sistema di relazioni più collaborative tra fisco e contribuenti, particolarmente nei settori ad alta intensità tecnologica dove l’innovazione costituisce un fattore strategico di competitività.