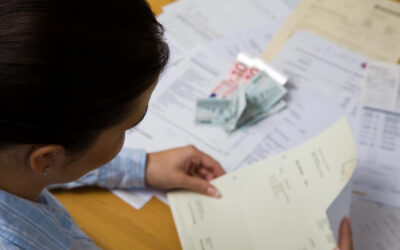L’associazione Assonime ha pubblicato nella circolare n. 20 del 31 luglio scorso un’analisi dettagliata delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 192/2024 in materia di contributi in conto capitale. La novità principale? L’eliminazione della possibilità di dilazionare la tassazione su più anni. Ora tutto si concentra nell’esercizio dell’incasso. Ma alcune questioni restano ancora aperte, soprattutto per quanto riguarda i contributi legati a studi e ricerche capitalizzati.
Il nuovo scenario normativo
L’articolo 9, comma 1, lettera a) del DLgs. 192/2024 ha riscritto le regole del gioco. Ha cancellato – e qui sta il punto centrale – quella facoltà che permetteva di spalmare la tassazione dei contributi in conto capitale su più esercizi (massimo cinque, compreso quello dell’incasso).
La modifica ha toccato l’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR. Prima si poteva scegliere: tassazione immediata oppure ripartizione temporale. Adesso questa seconda opzione non esiste più. I contributi in conto capitale seguono esclusivamente il principio di cassa: si tassano quando arrivano materialmente nelle casse dell’impresa.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto di riforma, le nuove disposizioni valgono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, si parte dal 2024.
Gestione dei contributi già incassati
Per i contributi ricevuti entro il 2023 continua a valere il regime precedente. Le imprese che avevano optato per la rateizzazione devono portare a termine il piano originario. Assonime chiarisce un aspetto importante: se uno stesso contributo viene erogato parte prima del 2024 e parte dopo, si applicano due discipline diverse.
La quota ricevuta prima del 2024 segue – eventualmente – la ripartizione già attivata. Quella incassata dal 2024 in poi subisce invece la tassazione integrale nell’esercizio di competenza.
Divergenze contabili che permangono
Nonostante l’intento semplificatore, restano alcune divergenze rispetto ai principi contabili. I documenti OIC 16 e OIC 24 prevedono la rilevazione dei contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni nel momento in cui sussiste ragionevole certezza del riconoscimento.
La riforma elimina solo la possibilità di dilazione fiscale. Ma non risolve lo sfasamento temporale tra rilevazione contabile (basata sulla certezza del diritto) e quella fiscale (legata all’incasso effettivo). Un piccolo passo verso l’allineamento, non una rivoluzione.
Il nodo dei contributi per ricerca e sviluppo
Ed è qui che la questione si complica. L’art. 108, comma 3 del TUIR stabilisce che per i contributi legati a costi per studi e ricerche si applica l’art. 88, comma 3. Ma cosa succede quando questi costi vengono capitalizzati?
Assonime evidenzia due possibili interpretazioni. La prima tesi sostiene che la norma riguarda tutti i tipi di contributi per ricerca, sia quelli relativi a costi imputati al conto economico sia quelli per costi capitalizzati (come immobilizzazioni immateriali in corso o costi di sviluppo).
Nella prassi contabile, però, questi ultimi contributi dovrebbero essere registrati in riduzione del costo delle immobilizzazioni oppure al conto economico con rinvio agli esercizi successivi tramite risconti passivi (come previsto dall’OIC 24). La tassazione immediata prevista dal nuovo decreto creerebbe un ulteriore disallineamento rispetto al momento di deducibilità dei costi oggetto di contribuzione.
L’interpretazione alternativa
La seconda tesi, più garantista, esclude dall’ambito dell’art. 108, comma 3 i contributi per ricerca relativi a costi capitalizzati. In questo caso la qualificazione contabile dovrebbe essere rispettata anche fiscalmente in virtù del principio di derivazione rafforzata. Conseguenza: tassazione secondo competenza e non per cassa.
Questioni aperte e auspici
Assonime chiede chiarimenti ufficiali su questo punto specifico. Nella casistica comune si incontrano spesso situazioni in cui la distinzione tra le due categorie di contributi non è così netta. L’esperienza applicativa suggerisce che una precisazione da parte dell’amministrazione finanziaria sarebbe utile.
La riforma rappresenta certamente un passo verso la semplificazione. Elimina una scelta che spesso generava incertezze applicative. Tuttavia, nell’ambito dei decreti correttivi che potrebbero seguire, sarebbe opportuno considerare ulteriori misure per ridurre le divergenze residue tra valori contabili e fiscali.
Il settore attende ora indicazioni operative più dettagliate, soprattutto per gestire i casi di transizione e le fattispecie più complesse legate alla ricerca e sviluppo.