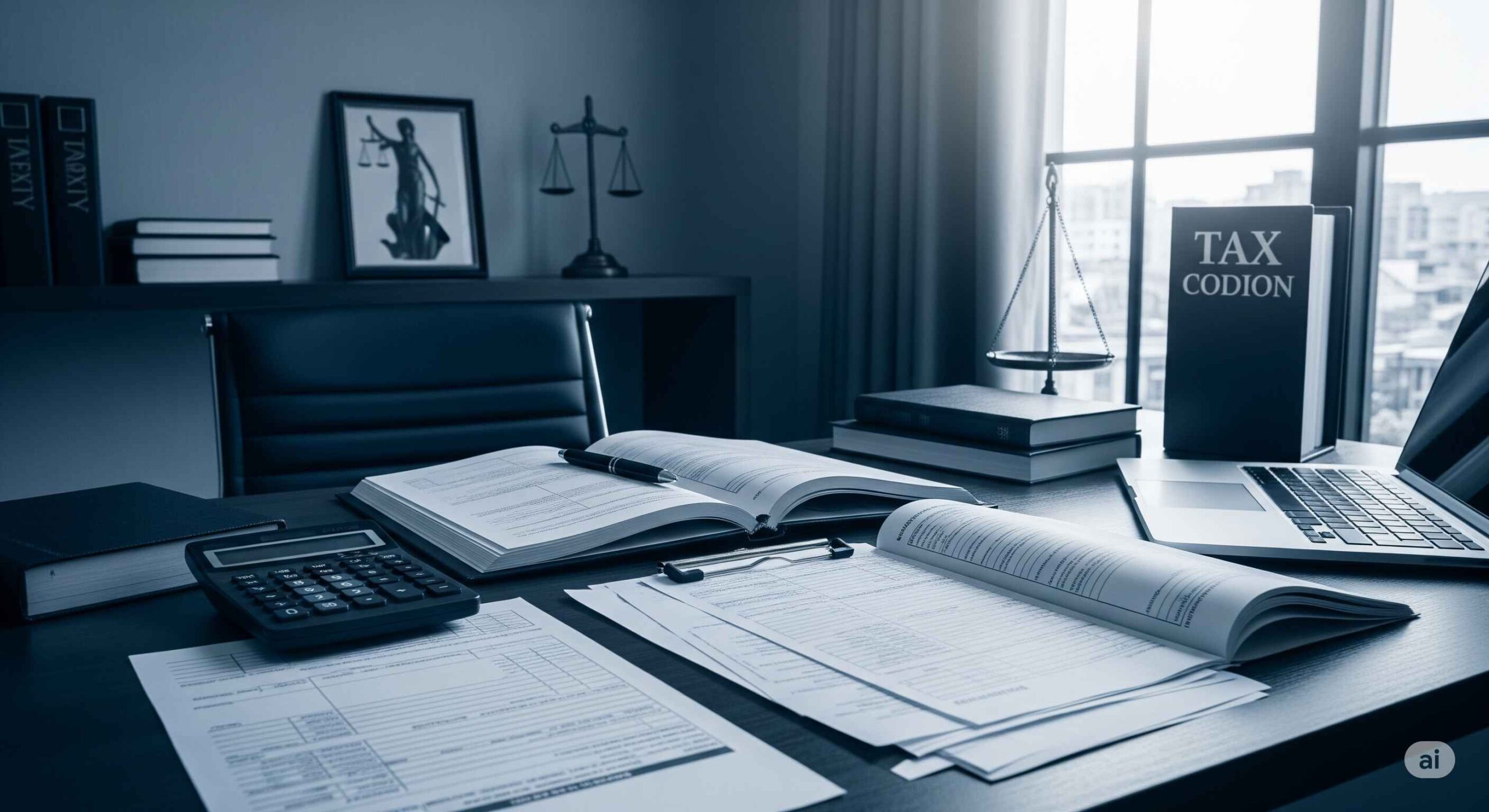La dichiarazione fraudolenta IVA continua a essere uno dei reati tributari più complessi dal punto di vista della responsabilità personale. La recente sentenza n. 25455 della Cassazione, depositata nel luglio 2025, ha ribadito un principio fondamentale: chi cessa dalla carica di amministratore prima della presentazione della dichiarazione non può essere chiamato a rispondere del reato, anche se ha partecipato alle fasi preparatorie della condotta fraudolenta. La questione, tutt’altro che teorica, si presenta frequentemente nella prassi professionale quando si verifica una successione tra diversi legali rappresentanti nel corso dello stesso periodo d’imposta. È opportuno notare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito definitivamente i confini temporali della responsabilità penale in materia di reati tributari dichiarativi.
|
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast. |
1
Natura bifasica del reato: quando si perfeziona la condotta
Il reato previsto dall’articolo 2 del DLgs. 74/2000 presenta, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, una natura bifasica particolarmente rilevante per determinare il momento della consumazione. La prima fase riguarda la raccolta o ricezione della documentazione inveritiera e la conseguente registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. Successivamente – e questo è il punto cruciale – vi è l’effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA.
Come spesso accade nella casistica giudiziaria, è proprio questa seconda fase che determina il perfezionamento del reato. Le Sezioni Unite, già con la pronuncia n. 27/2000, avevano precisato che il legislatore mira a reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali. Si deve quindi distinguere tra le condotte meramente preparatorie (acquisizione e registrazione di fatture false) e quella effettivamente lesiva (presentazione della dichiarazione).
Nell’esperienza applicativa si osserva frequentemente come questa distinzione temporale generi non poche difficoltà interpretative, specialmente quando le condotte preparatorie vengono poste in essere da un soggetto diverso da quello che poi presenta materialmente la dichiarazione.
Il momento della consumazione secondo la Cassazione
La giurisprudenza ha talvolta interpretato con rigore estremo il principio secondo cui il reato risulta integrato solo con la presentazione della dichiarazione. Ciò significa, in termini pratici, che le condotte pregresse restano sul piano penale del tutto irrilevanti e non possono nemmeno dare luogo a una forma di tentativo punibile.
È importante e fondamentale comprendere come questa impostazione rappresenti un’evoluzione rispetto alla precedente disciplina dell’articolo 4 della L. 516/1982, che prevedeva una diversa configurazione del momento consumativo. Secondo quanto previsto dall’attuale normativa, si devono tenere distinti i casi in cui vi è progressione nello stesso periodo d’imposta dall’utilizzazione alla dichiarazione (da qualificare ai sensi degli articoli 2 e 3 del DLgs. 74/2000) dai casi in cui si ha una dichiarazione di elementi passivi fittizi senza contemporaneo utilizzo della falsa rappresentazione nelle scritture contabili.
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 25455/2025, per esempio, non era sufficiente addurre che la fattura del dicembre 2014 non fosse stata annotata nell’anno di emissione, ma in quello successivo. Diviene invece necessario – come spesso accade nella pratica professionale – chiarire in quali dichiarazioni fiscali fosse poi confluito l’utilizzo di tale fattura.
Responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica
Soggetto responsabile della dichiarazione fraudolenta è esclusivamente colui che sottoscrive la dichiarazione, anche se non ha partecipato alla fase antecedente di acquisizione e registrazione delle fatture relative a operazioni inesistenti. Si tratta di un reato “proprio”, configurabile solo quando il suo autore si trovi in una particolare posizione soggettiva, giuridica o di fatto.
La Cassazione esclude pertanto categoricamente che possa essere chiamata a rispondere per la dichiarazione IVA 2017 la persona che rivestiva la carica formale di legale rappresentante sino all’ottobre 2016. Nella prassi si osserva come questa situazione si presenti frequentemente nelle società di capitali, dove i cambi di amministrazione possono verificarsi anche nel corso dell’anno.
Un aspetto spesso trascurato riguarda le modalità concrete di presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame, il documento era stato inviato telematicamente dal consulente fiscale e l’inserimento dei dati del precedente amministratore quale firmatario rappresentava non solo un’irregolarità formale, ma soprattutto non era indicativo della protrazione dell’attività gestoria. È necessario che tale protrazione sia confortata da ulteriori elementi probatori che la confermino.
Amministratore di fatto versus amministratore formale
Criticità ricorrenti emergono quando si deve valutare il ruolo dell’amministratore di fatto. Secondo quanto previsto dall’articolo 2639 del Codice Civile, sarebbe necessario accertare la sussistenza di quegli elementi sintomatici più volte dettagliati dalla giurisprudenza per configurare tale qualifica.
L’amministratore di fatto – come si deve considerare – non è automaticamente equiparabile a quello formale ai fini della responsabilità per dichiarazione fraudolenta. Occorre infatti dimostrare l’effettivo esercizio di poteri gestori nel momento della presentazione della dichiarazione. Si consideri che la mera impartizione di direttive o il controllo delle attività aziendali potrebbero non essere sufficienti se non accompagnati da un coinvolgimento diretto nella gestione fiscale.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo i requisiti per l’individuazione dell’amministratore di fatto, richiedendo la dimostrazione di un’ingerenza sistematica e continuativa negli affari sociali, particolarmente nell’ambito degli adempimenti fiscali.
Concorso nel reato: quando è possibile
Nella pratica professionale si osserva però che l’ex amministratore può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta quando abbia contribuito materialmente alla creazione del meccanismo fraudolento poi utilizzato dal successore. La sentenza n. 32237 del 2021 della Cassazione aveva infatti ritenuto configurabile il concorso nel reato anche per chi, pur non avendo firmato la dichiarazione, avesse partecipato a creare il sistema di evasione.
È opportuno notare come questa possibilità di concorso rappresenti una deroga importante al principio generale sopra esposto. Si deve tuttavia precisare che il contributo dell’ex amministratore deve essere causalmente collegato alla successiva presentazione della dichiarazione fraudolenta e non può limitarsi a mere condotte preparatorie prive di rilevanza causale.
Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza consolidata, è configurabile il concorso anche di “coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società – abbiano partecipato alla creazione di una frode fiscale utilizzata dall’amministratore” (Cassazione n. 35729/2013).
Aspetti procedurali e implicazioni pratiche
Dal punto di vista operativo (aspetti spesso trascurati nella letteratura specialistica), occorre prestare particolare attenzione alla corretta documentazione dei passaggi di consegne tra amministratori. La presenza di deleghe o procure che si prolungano oltre la cessazione formale dalla carica può infatti rappresentare un elemento di prova dell’effettiva prosecuzione dell’attività gestoria.
È fondamentale, nell’esperienza applicativa, che il consulente fiscale verifichi sempre l’effettiva legittimazione del soggetto che sottoscrive la dichiarazione al momento della presentazione. L’inserimento di dati relativi a soggetti non più in carica costituisce non solo un errore formale ma può generare problematiche interpretative in sede di eventuale procedimento penale.
La recente riforma del sistema sanzionatorio (DLgs. 158/2015) ha inoltre inasprito le pene per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, portando il massimo da sei a otto anni per le condotte più gravi. Ciò rende ancora più rilevante l’individuazione corretta del soggetto responsabile e la delimitazione temporale della condotta.