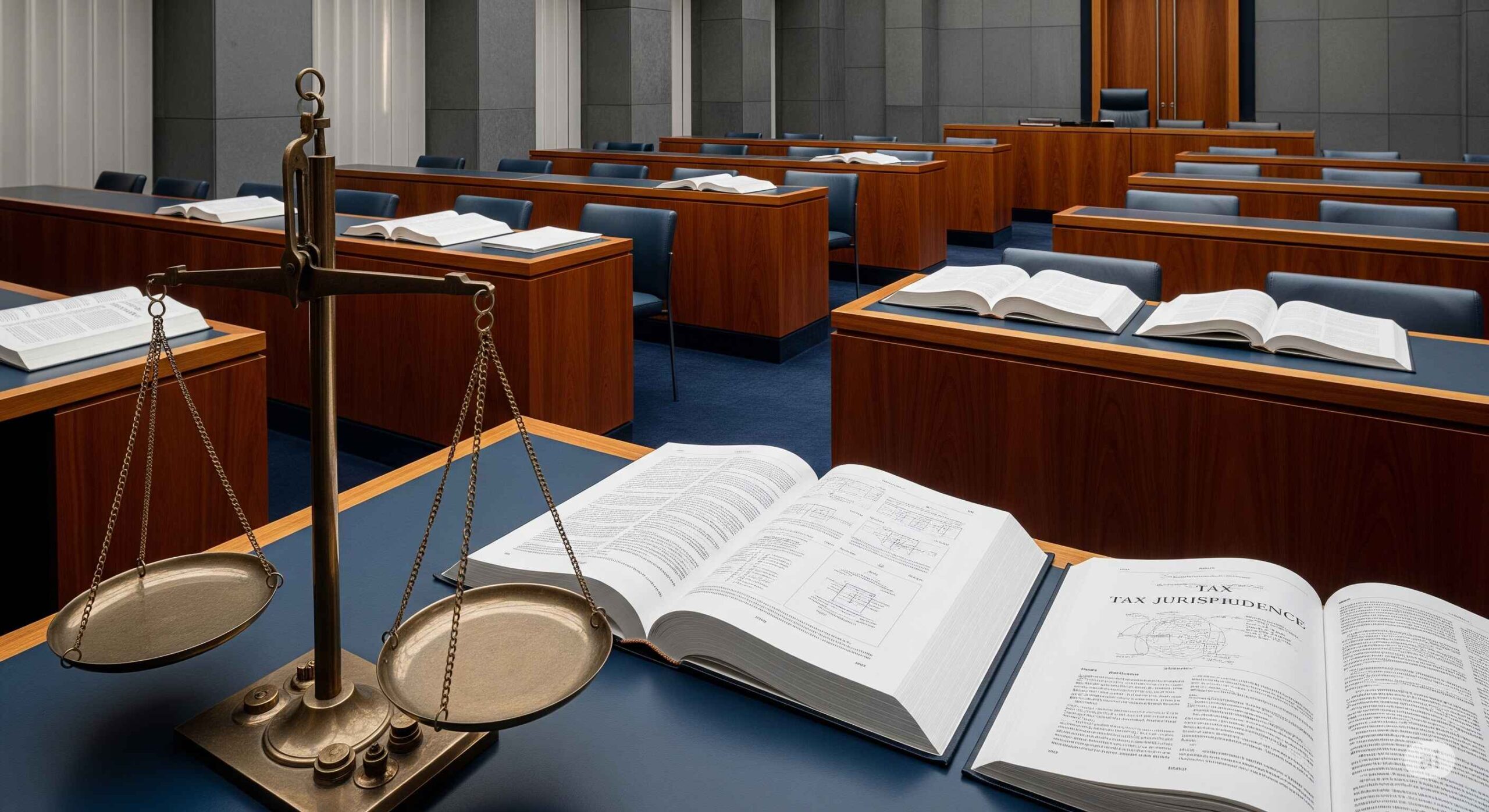Una sentenza destinata a riscrivere la prassi fiscale delle imprese. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 22822/2025, demolisce anni di interpretazioni ministeriali e restituisce alle società di capitali il diritto alla deducibilità IRAP ammortamento fabbricati in base alle sole risultanze contabili. L’Agenzia delle Entrate, che da oltre un decennio imponeva i criteri forfetari dell’IRES anche al tributo regionale, si trova ora di fronte a una clamorosa smentita giudiziaria. Il verdetto arriva dopo mesi di tensioni interpretative e segna il definitivo tramonto di una prassi amministrativa sempre più contestata dalla comunità professionale. Nel mirino finisce l’articolo 36 comma 7 del DL 223/2006 – quello che impone lo scorporo del 20-30% per il valore delle aree – la cui applicazione all’IRAP viene ora dichiarata del tutto illegittima per le società di capitali.
🕒 Cosa sapere in 1 minuto
- La Cassazione (sent. 22822/2025) ha sancito che l’ammortamento dei fabbricati è deducibile ai fini IRAP solo secondo le risultanze contabili, senza scorpori forfetari.
- Superato l’obbligo di riduzione del 20-30% per il terreno ai fini IRAP, valido solo per l’IRES: la norma non si applica alle società di capitali.
- Il principio di derivazione dal bilancio prevale: contano solo valori iscritti secondo i principi contabili, senza percentuali fisse.
- Possibili risparmi fiscali per chi ha applicato criteri forfetari in passato e margini di recupero su quote versate entro il termine di prescrizione.
- La novità si applica solo a società di capitali e società di persone “in bilancio”; restano i vecchi criteri per le società di persone in regime naturale.
- Attenzione in caso di verifica o contenzioso: si apre la strada al recupero di IRAP, ma occorre cautela operativa.
La sentenza che cambia il paradigma fiscale
Rottamazione quinquies
|
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast. |
Rottamazione quinquies
I supremi giudici non si limitano a una pronuncia di principio, ma entrano nel dettaglio tecnico-normativo con precisione chirurgica. La questione ruotava intorno a un’apparente lacuna: l’articolo 5 del DLgs. 446/97, nella versione modificata dalla legge 244/2007, non contiene alcun richiamo esplicito all’articolo 36 comma 7 del DL 223/2006.
Secondo la Cassazione, questa omissione non rappresenta una svista legislativa, bensì una scelta deliberata del legislatore del 2007. La riforma dell’IRAP ammortamento fabbricati aveva infatti introdotto il principio di derivazione diretta dal bilancio, creando – nelle parole della Corte – “una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell’IRES e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile IRAP”.
La sentenza n. 22822/2025 rappresenta la naturale evoluzione di un orientamento giurisprudenziale già consolidato per i contratti di leasing immobiliare. Con le precedenti pronunce nn. 6492/2023 e 7183/2021, la Cassazione aveva già stabilito che i canoni di locazione finanziaria dovessero seguire le risultanze del conto economico, senza applicare i criteri forfetari ministeriali.
Il crollo della costruzione ministeriale
Per oltre quindici anni, l’Agenzia delle Entrate aveva costruito un sistema interpretativo basato su fondamenta traballanti. Le circolari n. 36/2009 e 38/2010 si aggrappavano al “tenore letterale” dell’articolo 36, sostenendo che il generico riferimento alle “quote di ammortamento deducibili” dovesse estendersi automaticamente anche all’IRAP.
Una costruzione argomentativa che la stessa dottrina aveva sempre definito “estremamente debole”. Assonime, nella circolare n. 34/2009, aveva demolito pezzo per pezzo la tesi ministeriale, evidenziando come il principio di derivazione diretta dal bilancio rendesse inapplicabili le regole fiscali specifiche dell’IRES.
Ma l’Amministrazione finanziaria proseguiva imperterrita nella sua strada. Nelle istruzioni annuali al modello IRAP, ribadiva sistematicamente l’obbligo di operare le variazioni in aumento per la quota terreno. Una prassi che ora si rivela essere stata per anni in contrasto con il diritto vivente.
La sentenza cita espressamente l’OIC 16 al paragrafo 60, secondo cui “se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinare il corretto ammortamento”. Ma – e qui sta il punto cruciale – i principi contabili non prevedono percentuali forfetarie rigide come quelle imposte dall’articolo 36.
Analisi tecnica delle implicazioni operative
La portata della decisione emerge chiaramente dall’analisi dei casi pratici che ora dovranno essere rivisti. Consideriamo una società di capitali che nel 2020 ha acquisito un capannone industriale per 2 milioni di euro. Secondo la prassi ministeriale, avrebbe dovuto scorporare 600.000 euro (30%) come valore del terreno, ammortizzando ai fini IRAP solo 1,4 milioni.
Con il nuovo orientamento giurisprudenziale, se il bilancio non opera alcuno scorporo forfetario – limitandosi magari a una valutazione peritale che attribuisce al terreno 200.000 euro – l’ammortamento IRAP seguirà questa risultanza contabile. Un risparmio di imposta che, considerando l’aliquota media del 3,9%, può tradursi in diverse migliaia di euro annui.
Ma attenzione: la sentenza si applica solo alle società di capitali e alle società di persone che abbiano optato per il calcolo dell’imposta in base al bilancio. Per le società di persone in regime naturale, disciplinate dall’articolo 5-bis del DLgs. 446/97, rimangono in vigore i criteri forfetari dell’articolo 36. Una distinzione che riflette la diversa struttura normativa del tributo regionale.
Il ragionamento della Cassazione si estende naturalmente anche ai beni acquisiti in leasing finanziario. Come aveva già chiarito la sentenza n. 6492/2023, la quota capitale dei canoni deve essere dedotta per l’intero importo stanziato nella voce B.8 del conto economico, fatta salva solo la quota interessi che rimane indeducibile per espressa previsione normativa.
Le ripercussioni sul contenzioso in corso
Nella prassi professionale si osserva già un fermento significativo tra i consulenti fiscali, che stanno rivalutando posizioni processuali ritenute fino a ieri problematiche. La sentenza apre scenari inediti per il recupero di imposte versate in eccesso, anche se occorre muoversi con prudenza nei limiti della prescrizione quadriennale.
I contribuenti che negli anni passati hanno subito accertamenti per mancata applicazione dei criteri forfetari potrebbero ora invocare la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, come spesso accade nelle controversie tributarie, l’Agenzia delle Entrate tenderà probabilmente a resistere fino a quando l’orientamento non diventerà pacifico.
Particolarmente delicata la situazione delle verifiche fiscali in corso. Gli uffici dell’Amministrazione si trovano ora di fronte a un dilemma: proseguire con i rilievi secondo la prassi ministeriale (ormai smentita dalla Cassazione) o adeguarsi immediatamente al nuovo orientamento giurisprudenziale.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo i termini per il rimborso di tributi versati per errore interpretativo. Ma quando si tratta di applicazione di norme inesistenti – come nel caso dello scorporo forfetario IRAP per le società di capitali – i principi generali potrebbero essere più favorevoli ai contribuenti.
Il precedente dei canoni di leasing: un percorso tracciato
La decisione sui fabbricati in proprietà si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato per i contratti di locazione finanziaria. La Cassazione, con le sentenze nn. 6492/2023 e 7183/2021, aveva già demolito la tesi ministeriale sulla necessità di scorporare la quota terreno dai canoni di leasing.
Il ragionamento seguito dai supremi giudici era apparso subito logicamente inattaccabile: se la legge 244/2007 aveva introdotto il principio di derivazione diretta dal bilancio per l’IRAP, non potevano più trovare applicazione regole fiscali specifiche non richiamate espressamente nella disciplina del tributo regionale.
I principi contabili nazionali, infatti, non prevedono per i canoni di locazione lo scorporo della parte correlata al costo delle aree secondo parametri forfetari. Una considerazione che si estende naturalmente agli ammortamenti, dove l’OIC 16 impone lo scorporo “anche in base a stime” ma non secondo le rigide percentuali dell’articolo 36.
Aspetti spesso trascurati nella casistica applicativa
Nell’esperienza applicativa emergono diverse questioni interpretative che la sentenza aiuta a chiarire. Si pensi al caso di fabbricati per i quali il contribuente abbia volontariamente operato lo scorporo in bilancio, magari per allinearsi alle prassi ministeriali o per scelte gestionali autonome.
In tali situazioni, è opportuno notare che il principio di derivazione non impone di recuperare artificialmente quote di ammortamento che non risultano dal bilancio. La regola stabilita dalla Cassazione è chiara: seguono le risultanze contabili, qualunque esse siano, purché conformi ai principi contabili nazionali.
Altro profilo spesso sottovalutato riguarda i fabbricati acquisiti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 36 comma 7. Molte società non avevano mai operato lo scorporo forfetario per questi beni, continuando ad ammortizzare l’intero valore originario. La giurisprudenza conferma ora la correttezza di tale approccio, almeno ai fini IRAP.
Criticità ricorrenti si registrano anche nella determinazione del valore da attribuire alle aree quando il contribuente decide volontariamente di operare lo scorporo. L’OIC 16 prevede che il valore possa essere determinato “anche in base a stime”, aprendo a valutazioni peritali che potrebbero discostarsi significativamente dai parametri forfetari ministeriali.
Le prospettive di intervento normativo
Come spesso accade nelle controversie interpretative di maggiore rilievo, il contrasto tra prassi amministrativa e giurisprudenza potrebbe sollecitare un intervento chiarificatore del legislatore. Una modifica esplicita all’articolo 5 del DLgs. 446/97 potrebbe estendere anche all’IRAP i criteri forfetari dell’articolo 36, ma tale intervento richiederebbe una valutazione attenta degli impatti sulla base imponibile del tributo regionale.
D’altra parte, il legislatore potrebbe anche decidere di assecondare l’orientamento giurisprudenziale, magari introducendo specifiche disposizioni di coordinamento tra la disciplina IRES e quella IRAP. Una scelta che rifletterebbe la natura peculiare del tributo regionale, sempre più slegato dalle logiche delle imposte sui redditi.
Al momento, però, la strada tracciata dalla Cassazione appare giuridicamente solida e coerente con i principi introdotti dalla riforma del 2007. Il principio di derivazione diretta dal bilancio rappresenta uno dei pilastri della moderna disciplina IRAP e non può essere aggirato attraverso interpretazioni estensive di norme pensate per altri tributi.
L’evoluzione giurisprudenziale dimostra come il sistema fiscale italiano stia gradualmente maturando verso una maggiore autonomia dei singoli tributi, superando le sovrapposizioni e i richiami incrociati che spesso generano incertezze interpretative. Un processo che, pur comportando iniziali difficoltà applicative, dovrebbe nel lungo termine garantire maggiore chiarezza e prevedibilità per i contribuenti.