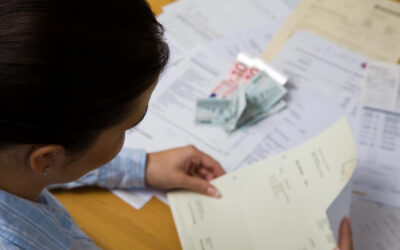L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27096/2025 rappresenta un punto di svolta nelle controversie relative alla qualificazione fiscale delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi. La pronuncia interviene su un quadro normativo tradizionalmente complesso, in cui l’assenza di previsioni legislative esplicite ha determinato nel tempo orientamenti giurisprudenziali divergenti e prassi amministrative inconsistenti. La sentenza ribadisce un principio di rilievo considerevole: l’esigenza che sussistano elementi certi e precisi per legittimare la deduzione delle perdite non presuppone necessariamente l’esistenza di una procedura concorsuale formale nei confronti del debitore. Trova piuttosto fondamento nel carattere oggettivo e documentato della scelta di transigere, nella ragionevolezza economica della rinuncia parziale al credito originario. Questo orientamento segna una discontinuità notevole rispetto alle prassi applicative precedenti, nelle quali l’Amministrazione finanziaria sistematicamente contestava la deducibilità in assenza di dichiarazioni giudiziali di insolvenza.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La Cassazione (ord. n. 27096/2025) consente la deduzione fiscale delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi con il debitore, senza richiesta di procedura concorsuale formale.
- Requisiti essenziali: elementi certi e precisi che rendono ragionevole la scelta di transigere (bilancio del debitore, tentative di recupero, comunicazioni, difficoltà finanziarie documentate). La perdita deve risultare documentata in modo chiaro.
- Filtro dell’inerenza: gli oneri transattivi devono essere collegati al concreto svolgimento dell’attività d’impresa. Transazioni su controversie contrattuali ordinarie: deducibili. Transazioni per danni extracontrattuali o illeciti: indeducibili.
- Tempistica: la deduzione può avvenire nell’anno in cui ricorrono gli elementi certi e precisi o nell’esercizio di cancellazione dal bilancio, secondo l’OIC 15.
- Soglie semplificate: crediti scaduti da oltre 6 mesi e sotto 2.500 euro (5.000 per grandi imprese) sono deducibili automaticamente.
La strada del compromesso non è sempre un sacrificio
Esiste una questione che affatica gli uffici tributari da anni: quando un creditore accetta di incassare meno di quello che gli spetta, il fisco lo concede come perdita deducibile? La domanda non è oziosa. Praticamente ogni azienda si trova prima o poi in questa situazione: il debitore è in difficoltà, recuperare il 100% costa più di quanto si perderebbe, oppure il rapporto commerciale vale più di una causa lunga e onerosa. Ecco che scatta la trattativa, la riduzione concordata del debito, il sollievo (temporaneo) di entrambi. Ma qui inizia il problema vero, quello fiscale.
L’ordinanza n. 27096/2025 della Corte di Cassazione arriva a tracciare un confine più netto. In sostanza: sì, potete dedurre quella perdita. Ma a patto che riusciate a dimostrare che la vostra scelta era ragionevole, documentata, supportata da fatti concreti e oggettivi. Non serve, però, affannarsi a provare che il debitore fosse tecnicamente “insolvente” dal punto di vista giuridico.
La normativa: cosa dice davvero l’articolo 101
La norma di riferimento è l’articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR). Essa consente la deduzione delle perdite su crediti, ma – ecco il punto critico – soltanto se ricorrono elementi certi e precisi. In mancanza di una procedura concorsuale formale (fallimento, amministrazione straordinaria e simili), la certezza e la precisione devono essere dimostrate. Non è un vago concetto: la norma stessa rimanda ai principi contabili nazionali per ancorare questi elementi a qualcosa di solido.
Per chi applica i principi contabili OIC (l’Organismo Italiano di Contabilità), entra in gioco il documento OIC n. 15, che disciplina il trattamento dei crediti. Secondo questo principio, il credito può essere cancellato dal bilancio – e quindi la perdita diventa automaticamente deducibile – quando i “diritti contrattuali sui flussi finanziari” si estinguono. Una transazione, in sostanza, estingue completamente (o parzialmente) il flusso di cassa atteso dal credito originario. Da qui deriva la legittimità della deduzione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2014 ha già chiarito che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi contemplate dall’OIC 15. Il problema, però, era che l’OIC 15 nell’appendice A non citava esplicitamente la transazione tra i casi di cancellazione ammessa. Proprio questo vuoto ha generato anni di controversie.
Cassazione: la transazione entra nella categoria
La Cassazione con l’ordinanza n. 27096/2025 ha fatto chiarezza. Ha ribadito – in linea con precedenti orientamenti, come la sentenza n. 10643/2018 – che la transazione intervenuta tra creditore e debitore legittima pienamente la deduzione della perdita derivante. Nessuna distinzione di sorta a seconda da cosa sia stata determinata la transazione stessa.
Il ragionamento della Corte è solido: l’OIC 15 afferma chiaramente che l’elenco nell’appendice A non è tassativo, cioè non esaurisce tutte le fattispecie. Dunque, se la transazione comporta l’estinzione dei flussi finanziari (come certamente accade), rientra legittimamente nei casi di cancellazione. Inoltre – e qui c’è un elemento importante – lo stesso OIC 15 al paragrafo 26 cita esplicitamente le perdite su crediti derivanti da transazione tra le perdite “realizzate”. Non si tratta quindi di valutazioni prudenziali, ma di perdite già perfezionatesi.
Su questa base, la Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla deducibilità della perdita si fonda su fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta di transigere per un importo inferiore. Non occorre che il creditore dimostri di essersi attivato positivamente per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore. È sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso.
Pensate, ad esempio, a una società che transige con un cliente dopo aver ricevuto il suo bilancio che evidenzia una situazione di grave difficoltà finanziaria. O ancora, a un creditore che negozia una riduzione quando apprende della condotta sistematica di mancato pagamento da parte del debitore. Questi “fatti oggettivi” sono sufficienti.
Il filtro dell’inerenza: non tutte le transazioni passano
Attenzione, però. La deducibilità degli oneri derivanti da accordi transattivi dev’essere vagliata anche attraverso il prisma dell’inerenza. Cioè: la spesa deve essere effettivamente collegata allo svolgimento dell’attività di impresa. Non tutto ciò che viene pagato in una transazione è automaticamente deducibile.
La sentenza della Cassazione n. 28355/2019 ha stabilito che sono deducibili i costi sostenuti, ad esempio, da una banca a titolo di transazione con clienti, quando mirano a prevenire controversie sulla responsabilità della banca stessa nell’erogazione dei servizi finanziari. Si tratta di somme attinenti al concreto svolgimento dell’attività e alla responsabilità contrattuale, dunque inerenti. La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491/2022 ha confermato questo orientamento: i risarcimenti danni versati a seguito di transazione sono deducibili perché collegati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se derivanti da violazione di obblighi contrattuali.
Ma attenzione al rovescio della medaglia. L’ordinanza n. 31930/2021 della Cassazione ha ritenuto indeducibili i pagamenti effettuati per transigere controversie derivanti da danni alla salute causati dall’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa. In questo caso, il ragionamento della Corte è stato che si trattava di risarcimenti derivanti da scelte imprenditoriali contrarie alla legge, che per loro natura esulano dalla sfera aziendale ordinaria. Non sono costi di gestione: sono “sanzioni” economiche per violazioni contra ius, e come tali restano indeducibili.
Questo significa che il contribuente deve sempre domandarsi: la transazione riguarda una controversia attinente al normale corso dell’attività? O affrontala una materia di responsabilità extracontrattuale, illeciti penali o violazioni norma? Nel primo caso, la strada per la deduzione è più agevole. Nel secondo, il fisco ha fondamenti solidi per contestare.
Gli elementi certi e precisi: come costruirli
Alla luce di quanto illustrato, costruire una documentazione robusta è fondamentale. Quando decidete di transigere, conservate:
- La documentazione relativa alle difficoltà finanziarie del debitore. Un bilancio, uno stato patrimoniale, comunicazioni dalla banca del debitore, notizie di procedure concorsuali avviate. Tutto ciò che renda oggettivamente razionale la vostra scelta di accettare meno di quanto dovuto.
- I tentativi di recupero precedenti. Lettere di sollecito, diffide, comunicazioni via pec. Mostrano che il credito era effettivamente problematico prima della transazione.
- L’accordo transattivo vero e proprio. Deve essere redatto con chiarezza, indicare l’importo originario, quello concordato, le motivazioni della riduzione. Quando successivamente cancellate il credito dal bilancio, l’accordo diventa la base della vostra deduzione.
- Il collegamento con il principio contabile applicato. Nel bilancio, illustrate le ragioni della cancellazione del credito con riferimento all’OIC 15 (o all’IFRS 9 se adottato). Questo “dialogo” tra bilancio e fisco è sempre utile.
Un piccolo dettaglio: la deduzione della perdita può avvenire nell’anno in cui gli elementi certi e precisi ricorrono. Non siete obbligati a dedurre tutto nell’esercizio della transazione. Potete anche attendere l’esercizio in cui stralciate effettivamente il credito dal bilancio. La flessibilità è concessa, ma deve rimanere ragionevole: non potete usarla per “spostare” arbitrariamente le perdite da un esercizio all’altro in funzione di obiettivi di bilancio.
Oltre la transazione: i crediti di modesto importo
Vale la pena ricordare che esiste anche una strada “semplificata” per crediti di piccola dimensione. L’articolo 101, comma 5, TUIR, prevede che i crediti scaduti da almeno 6 mesi e di importo inferiore a 2.500 euro sono deducibili in quanto ricorrono elementi certi e precisi per definizione. Per le imprese di maggiori dimensioni (ricavi oltre 100 milioni di euro), la soglia sale a 5.000 euro. In questi casi, non serve neppure provare la ragionevolezza della perdita: la norma la presume.
Diverso è il caso dei crediti verso debitori in procedure concorsuali. Qui gli elementi certi e precisi sussistono “in ogni caso” dal momento in cui il debitore è sottoposto a fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento. Non occorre aspettare la cancellazione dal bilancio: la procedura fa scattare automaticamente la deducibilità, se documentata.
Un ultimo aspetto: le sopravvenienze
Nella pratica professionale si osserva una criticità che sfugge spesso. Non ogni riduzione di credito è “perdita su crediti”. Se la transazione avviene non perché il debitore è in difficoltà, ma perché contestate la qualità della fornitura, il prezzo, la prestazione, allora quella riduzione potrebbe qualificarsi come “sopravvenienza passiva” e non come perdita su crediti. La distinzione conta enormemente ai fini IRAP: le sopravvenienze passive correlate a componenti imponibili sono comunque deducibili, mentre le perdite seguono le regole più rigide dell’articolo 101.
La circolare 26/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate già lo chiariva, ma rimane un aspetto facilmente confondibile. Occorre quindi che la qualificazione della transazione sia il più possibile esplicita già nel documento stesso: “transazione per difficoltà finanziarie del debitore” oppure “transazione per contestazione sulla qualità della fornitura”? Il linguaggio che usate avrà conseguenze tributarie non trascurabili.
Cosa comporta concretamente la sentenza
L’ordinanza della Cassazione rafforza significativamente la posizione dei contribuenti. Prima di questo clarimento, il Fisco contestava sistematicamente la deducibilità delle perdite da transazione, sostenendo che in assenza di una procedura concorsuale formale mancassero gli “elementi certi e precisi” richiesti dalla legge. Adesso, il dovere di provare la ragionevolezza economica della transazione rimane, ma il banco della prova non è più impossibile da superare.
Una sentenza di giudice, un bilancio della società debitrice, una serie di comunicazioni che documentino la difficoltà del debitore: questi elementi “ordinari”, che quasi sempre un creditore attento conserva, sono ormai sufficienti.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: il legislatore non intende penalizzare chi, dinanzi a una situazione reale di difficoltà del debitore, sceglie di raggiungere un compromesso. Al contrario, riconosce che spesso questa è la scelta più economicamente razionale, perché evita i costi di una causa e recupera comunque qualcosa anziché nulla. Che questa scelta sia consapevole, documentata e supportata da fatti concreti, lo Stato lo richiede. Ma non lo proibisce.