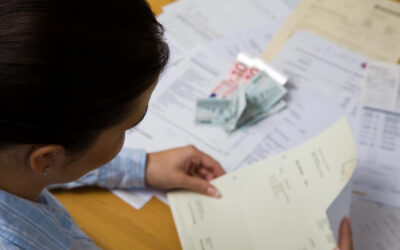Con l’introduzione dell’articolo 54-sexies nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il legislatore ha modificato il regime fiscale applicabile ai professionisti. Ora diventa possibile dedurre, attraverso quote di ammortamento, i costi sostenuti per l’acquisizione di specifici beni immateriali. Un cambiamento che, nella prassi operativa, allinea parzialmente il trattamento dei lavoratori autonomi a quanto già previsto per le imprese.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La riforma (art. 54-sexies TUIR) consente agli autonomi di ammortizzare i costi per tre categorie di beni immateriali: diritti di utilizzazione (brevetti, opere dell’ingegno), altri diritti pluriennali, acquisizione di clientela.
- La deduzione annuale varia: massimo 50% in 2 anni per diritti d’utilizzazione; in base alla durata contrattuale per altri diritti; un quinto all’anno in 5 anni per l’acquisizione di clientela.
- Decorrenza differenziata: le prime due categorie sono deducibili già dal 2024 (Redditi 2025); l’acquisizione clientela da Redditi 2026 (anno 2025).
- Superato il principio di cassa: ora il costo è deducibile per competenza secondo utilità pluriennale.
- Attenzione a documentazione e classificazione: occorre conservare prova del costo sostenuto e della durata. Dubbi interpretativi potrebbero essere chiariti dall’Agenzia.
Le tre categorie di beni ammortizzabili
La normativa individua tre distinte tipologie di elementi patrimoniali immateriali. Ciascuna categoria segue regole proprie per il calcolo della deducibilità.
Si consideri innanzitutto i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno e brevetti industriali, categoria che comprende anche processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 54-sexies TUIR, l’ammortamento avviene con una quota massima annua pari al 50% del costo sostenuto. In sostanza, il professionista può spalmare la deduzione su un arco temporale minimo di due anni.
La seconda categoria riguarda altri diritti di natura pluriennale. Qui il meccanismo cambia: occorre fare riferimento alla durata prevista nel contratto di acquisizione o, in alternativa, a quella stabilita dalla legge. Come spesso accade nella disciplina fiscale, il principio guida diventa la correlazione tra utilità economica del bene e periodo di deduzione del suo costo.
Terza ed ultima tipologia: l’acquisizione della clientela e degli elementi immateriali connessi alla denominazione o ad altri segni distintivi dell’attività professionale. Per questi asset la deduzione è limitata a un quinto del costo annualmente. Vale a dire che l’ammortamento si completa in un minimo di cinque anni.
Decorrenze differenziate: quando applicare le nuove regole
Il legislatore ha previsto due diverse decorrenze. Non è un dettaglio secondario.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2024, le prime due categorie (diritti su opere dell’ingegno e altri diritti pluriennali) producono effetti già per i redditi 2024. I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno quindi applicare le nuove disposizioni nel modello Redditi 2025. L’entrata in vigore è stata quindi immediata.
Diversa la tempistica per l’acquisizione della clientela e gli elementi distintivi. Il comma 4 dello stesso decreto rinvia l’applicazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Tradotto: per i contribuenti solari, il debutto avverrà con il modello Redditi 2026, relativo all’anno 2025.
Il superamento del principio di cassa
Prima dell’intervento normativo, la disciplina del reddito di lavoro autonomo non contemplava alcuna forma di ammortamento per queste voci di costo. Il professionista applicava il criterio di cassa: deduzione integrale nell’anno di sostenimento della spesa. Non importava se l’utilità del bene si sarebbe protratta negli anni successivi.
La riforma introduce dunque un elemento di maggior razionalità. Nella pratica professionale si osserva come l’acquisizione di brevetti o di un portafoglio clienti generi benefici economici su più esercizi. È opportuno notare che il nuovo meccanismo consente di distribuire la deduzione in coerenza con tale effettiva durata.
Aspetti applicativi e casistica ricorrente
Si prenda ad esempio un commercialista che, nel 2024, acquista un software gestionale con licenza d’uso quinquennale al costo di 10.000 euro. Trattandosi di diritto pluriennale (seconda categoria), potrà dedurre annualmente 2.000 euro per cinque anni, seguendo la durata contrattuale.
Oppure si consideri un professionista tecnico che sviluppa internamente un processo brevettato, sostenendo costi per 15.000 euro nel 2024. Rientrando nella prima categoria, il minimo ammortamento sarà biennale: 7.500 euro annui per due anni (salvo scelta di un piano più lungo).
Diverso ancora il caso di un avvocato che rileva uno studio professionale nel 2025, pagando 50.000 euro per l’avviamento e la clientela. Qui occorre attendere il modello Redditi 2026 per iniziare a dedurre 10.000 euro all’anno per cinque esercizi.
Profili di criticità interpretativa
Permangono alcune zone d’ombra. La qualificazione di un asset come “diritto pluriennale” piuttosto che come “elemento distintivo” può generare incertezze. E con essa, conseguenze sulla durata dell’ammortamento. La prassi amministrativa dovrà probabilmente intervenire con chiarimenti.
Altro aspetto talvolta trascurato: la documentazione. Il professionista deve conservare evidenza sia del costo sostenuto che della durata prevista, specialmente per i diritti contrattuali. Senza una corretta profilatura documentale, la deduzione potrebbe essere contestata in sede di controllo.