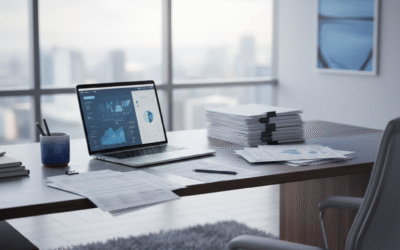Si prospetta un quadro di complessità notevole per i contribuenti chiamati a regolarizzare la propria posizione fiscale nell’estate 2025. Le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge n. 84/2025 hanno infatti configurato uno scenario a doppia velocità, che distingue nettamente tra categorie di soggetti passivi, creando nella prassi applicativa una serie di interrogativi non sempre di agevole risoluzione. La normativa in esame – e questa rappresenta forse l’aspetto più peculiare dell’intervento – non si limita a prorogare uniformemente i termini di pagamento, come spesso accaduto in passato, ma opera una distinzione selettiva che rischia di generare, almeno nella fase iniziale di applicazione, una certa confusione operativa.
|
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast. |
1
Chi beneficia della proroga al 21 luglio: i criteri selettivi
La proroga al 21 luglio 2025, disposta dall’articolo 13 del D.L. n. 84/2025, si applica esclusivamente ai contribuenti che soddisfano criteri piuttosto specifici, talvolta non immediatamente evidenti. Si tratta, in primo luogo, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – i cosiddetti ISA – purché dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite di 5.164.569 euro stabilito dai relativi decreti ministeriali.
Un aspetto che merita particolare attenzione, e che nella casistica più comune genera perplessità, riguarda l’estensione della proroga ai contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, pur non applicando materialmente gli ISA, beneficiano comunque del differimento in ragione dell’esistenza di un modello ISA “virtualmente” applicabile all’attività da essi esercitata. Tale impostazione, che potrebbe apparire anomala a prima vista, trova la sua ratio nella volontà del legislatore di non penalizzare categorie di contribuenti che, seppur in regimi fiscali diversi, operano in settori economici omogenei.
Risultano invece esclusi dalla proroga, con ciò mantenendo la scadenza ordinaria del 30 giugno, i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole e sono titolari di soli redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR. Tale esclusione appare coerente con la struttura dell’intervento normativo, che mira essenzialmente a supportare le attività economiche sottoposte a forme di monitoraggio tramite ISA.
I soggetti esclusi: scadenza ferma al 30 giugno
Per tutti gli altri contribuenti, il termine del 30 giugno 2025 rimane immutato e rappresenta la scadenza tassativa per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025. Questa categoria comprende, nella prassi più ricorrente, le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, nemmeno attraverso partecipazioni in società o associazioni trasparenti.
Rientrano altresì nella scadenza ordinaria i contribuenti che, pur svolgendo attività d’impresa o di lavoro autonomo, operano in settori per i quali non sono stati approvati gli ISA, ovvero quelli che, pur operando in settori ISA, dichiarano ricavi o compensi superiori al limite quinquennale stabilito.
L’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 consente tuttavia anche a questi soggetti di differire il pagamento di ulteriori trenta giorni, versando entro il 30 luglio 2025 con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Il calcolo degli acconti 2025: le modifiche strutturali
Ai fini della determinazione degli acconti 2025, assume rilevanza decisiva l’intervento operato dal decreto Acconti (D.L. n. 55/2025, convertito dalla legge 19 giugno 2025, n. 86). Tale provvedimento ha eliminato il riferimento all’anno 2025 dal comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023, con la conseguenza che per la determinazione degli acconti IRPEF e delle relative addizionali si applicano definitivamente le tre aliquote IRPEF strutturali:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro.
- 25% per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro.
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.
Parallelamente, trova applicazione l’incremento delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, che passano da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025.
Modalità di versamento: unica soluzione o rateizzazione
Il metodo di calcolo dell’acconto può seguire il criterio storico, basato sull’imposta dell’anno precedente, ovvero quello previsionale, qualora si presuma per l’anno in corso un risultato economico inferiore. La scelta tra i due metodi, come spesso accade nella prassi professionale, richiede una valutazione attenta delle prospettive reddituali del contribuente.
Le modalità di versamento variano in funzione dell’importo dovuto:
- versamento unico entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) per acconti inferiori a 257,52 euro ma superiori a 52 euro.
- versamento in due rate per acconti pari o superiori a 257,52 euro: la prima del 40% insieme al saldo, la seconda del 60% entro il 1° dicembre 2025.
La disciplina IRES: termini differenziati per tipologia societaria
Per i soggetti passivi IRES che non beneficiano della proroga, la casistica applicativa presenta maggiore articolazione. Il versamento deve essere effettuato:
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (30 giugno per esercizi solari con approvazione del bilancio nei termini ordinari).
- entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione del bilancio per società con approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si prevede anche per l’IRES la possibilità di differimento trentennale con maggiorazione dello 0,40%, meccanismo che nella pratica professionale viene spesso utilizzato per esigenze di tesoreria.
Rateizzazione: un’opzione da valutare attentamente
L’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997 consente la rateizzazione mensile dei versamenti, con completamento entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi applicabili sono pari allo 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, mentre l’acconto di novembre non può essere oggetto di rateizzazione.
Un aspetto tecnico spesso trascurato riguarda il trattamento della maggiorazione: qualora la prima rata venga versata entro il 30 luglio 2025 (anziché il 30 giugno), l’intero debito da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,4%. Tale meccanismo, che può apparire penalizzante, trova la sua giustificazione nella necessità di mantenere coerenza tra i diversi istituti di differimento del pagamento.
La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti: è possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo, configurando così strategie di pagamento personalizzate in base alle specifiche esigenze di liquidità.