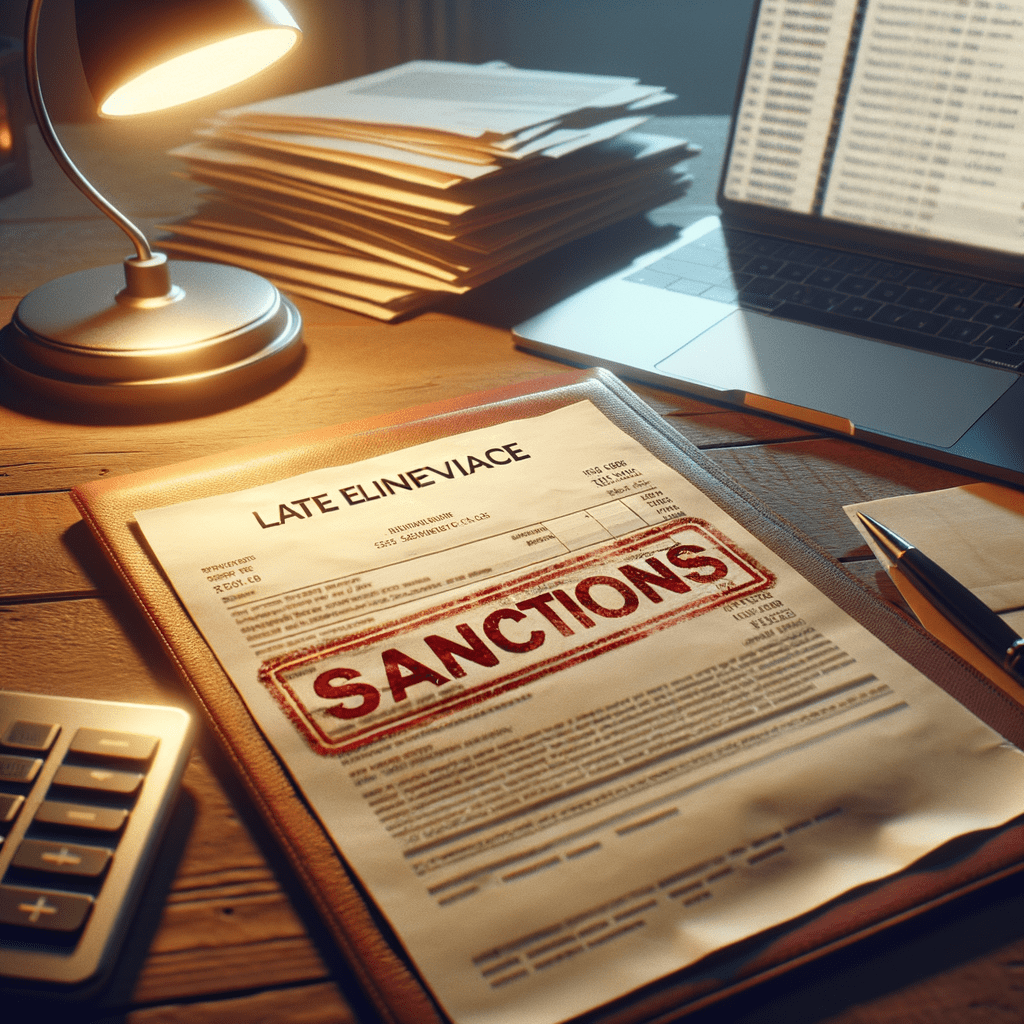La Cassazione torna sul tema della responsabilità per le sanzioni fiscali comminate a società ed enti collettivi. Attraverso l’ordinanza n. 28888 emessa il primo novembre 2025, i giudici di legittimità ricostruiscono un quadro normativo complesso, stratificato nel tempo, che distingue nettamente tra realtà dotate di personalità giuridica e quelle che ne sono prive. Una distinzione non meramente formale ma che incide in modo diretto sul patrimonio dei soggetti coinvolti nella gestione d’impresa. La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguardava una società in accomandita semplice (quindi priva di quella autonomia patrimoniale perfetta tipica delle società di capitali) per violazioni accertate nell’anno fiscale 2008. L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato le relative penalità, ma la società contestava la legittimità delle stesse sostenendo che l’illecito fosse imputabile esclusivamente all’ex socio accomandatario, ormai fuoriuscito dalla compagine sociale.
🕒 Cosa sapere in un minuto
Evoluzione normativa
- Dal 2003 esiste un sistema binario: società di capitali rispondono in via esclusiva, società di persone in via solidale
- Dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024 estende la responsabilità esclusiva anche alle società di persone
- Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Testo Unico delle sanzioni (D.Lgs. 173/2024) che riordina tutta la materia
Chi risponde delle sanzioni
- Società di capitali (Spa, Srl): rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio sociale
- Società di persone (Snc, Sas): la sanzione è a carico della società, ma resta la responsabilità solidale dei soci in fase di riscossione
- Enti privi di personalità giuridica: stesse regole delle società di persone
Società fittizie
- Se la società è costituita solo sulla carta senza reale attività, la sanzione colpisce direttamente la persona fisica che ha agito
- L’Amministrazione finanziaria deve provare la natura fittizia della struttura societaria
Cassazione 28888/2025
- Per le violazioni commesse prima di settembre 2024 si applica il regime precedente (sistema binario)
- Nelle società di persone la responsabilità solidale include anche i soci uscenti per violazioni commesse durante il loro mandato
Implicazioni pratiche
- La scelta della forma societaria ha impatto diretto sulla responsabilità sanzionatoria
- I soci di società di persone devono considerare il rischio di esposizione del proprio patrimonio personale
- La solidarietà opera solo nella fase di riscossione, non più al momento dell’irrogazione
1
Come sono cambiate le regole dal 2003
Prima dell’intervento del 2003, la disciplina applicabile era quella contenuta nel Decreto Legislativo 472 del 1997, precisamente nell’articolo 11. Secondo tale impianto, l’Amministrazione finanziaria disponeva di ampia discrezionalità: poteva rivolgersi indifferentemente all’autore materiale della violazione oppure all’ente che aveva beneficiato economicamente dalla condotta illecita. Si trattava, nella sostanza, di una responsabilità congiunta e solidale.
Il sistema così delineato presentava però una lacuna evidente: non operava alcuna distinzione tra le diverse configurazioni societarie. Società di persone, società di capitali ed enti non riconosciuti venivano considerati alla stessa stregua, nonostante le profonde differenze nella loro struttura giuridica e patrimoniale. Una società per azioni con patrimonio autonomo finiva per essere trattata come una società in nome collettivo, dove i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale.
Con l’articolo 7 del Decreto Legge 269/2003 (successivamente convertito nella Legge 326/2003), il legislatore ha operato una scelta precisa. Per gli enti dotati di personalità giuridica, la responsabilità sanzionatoria ricade esclusivamente sulla persona giuridica stessa, svincolando completamente le persone fisiche che abbiano agito per suo conto. Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento del 2003, l’obiettivo era rafforzare le garanzie di recupero delle somme dovute, concentrando l’obbligazione sul soggetto che aveva effettivamente tratto vantaggio dall’infrazione.
Il sistema binario applicabile fino a settembre 2024
Nella prassi, si è venuto a creare quello che la giurisprudenza definisce un “sistema binario”. Da una parte troviamo le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) che rispondono in via esclusiva delle sanzioni tributarie relative al proprio rapporto fiscale. Dall’altra parte, le società di persone (Snc, Sas) e gli enti privi di personalità giuridica continuano a rispondere secondo il regime di solidarietà previsto dall’articolo 11 del DLgs 472/1997.
Occorre comprendere cosa significa nella pratica questa distinzione. Prendiamo il caso di una Srl che omette di versare le ritenute d’acconto: la sanzione verrà irrogata esclusivamente nei confronti della società, senza che l’amministratore possa essere chiamato personalmente a rispondere. Diverso il caso di una Snc che commette la stessa violazione: qui l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sia sul patrimonio sociale che su quello personale dei soci, secondo quanto previsto dalle norme sulla responsabilità solidale del codice civile.
Nella giurisprudenza tributaria si è consolidato il principio secondo cui nelle società dotate di personalità giuridica viene meno qualsiasi riferibilità alle persone fisiche agenti. La sanzione segue la violazione commessa nell’interesse della società, prescindendo dall’elemento psicologico con cui l’illecito è stato posto in essere e dal vantaggio economico effettivamente conseguito. L’obbligazione sanzionatoria si radica direttamente in capo all’ente, quale soggetto autonomo rispetto ai propri organi.
Le novità introdotte dal 2024 in poi
Settembre 2024 ha segnato una svolta significativa con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 87 del 18 giugno 2024, recante la revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del DLgs 472/1997 ha introdotto una regolamentazione più articolata.
Per le società di capitali rimane fermo il principio della responsabilità esclusiva: il patrimonio sociale costituisce l’unico aggredibile per il soddisfacimento delle pretese sanzionatorie dell’Erario. L’autonomia patrimoniale perfetta che le caratterizza fa sì che soci e amministratori restino al riparo da ripercussioni dirette sul proprio patrimonio personale.
Le società di persone e gli enti privi di personalità giuridica continuano invece a soggiaccere al principio di solidarietà. La sanzione può colpire tanto il patrimonio dell’ente quanto quello dei singoli soci che hanno partecipato alla gestione. Nella fase di riscossione trovano applicazione le disposizioni civilistiche che regolano la responsabilità solidale e sussidiaria.
Una novità assoluta riguarda le ipotesi di fittizia costituzione o interposizione. Quando viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica rappresentano soltanto uno schermo, privo di effettiva sostanza economica, la sanzione viene irrogata direttamente nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto. Si tratta di una norma antielusiva che mira a colpire chi utilizza strutture societarie artificiose per sottrarsi alle proprie responsabilità fiscali.
Il testo unico che riordina la materia
Nella prassi, il Decreto Legislativo 87/2024 ha avuto vita brevissima. Il 5 novembre 2024 è stato emanato il Decreto Legislativo 173, contenente il Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024, questo provvedimento riordina in un corpus normativo unitario tutte le disposizioni vigenti in materia sanzionatoria.
L’articolo 10 del nuovo Testo Unico stabilisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti – sia con che senza personalità giuridica, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 73 del TUIR – è esclusivamente a carico della società o ente. Si conferma dunque il superamento del sistema binario precedente, estendendo anche alle società di persone il principio della responsabilità primaria dell’ente.
Resta ferma, però, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. In altri termini: l’irrogazione della sanzione avviene nei confronti della società, ma se questa non adempie, il Fisco può rivalersi sui soci secondo le regole ordinarie.
L’elemento di maggior rilievo riguarda sempre le società fittizie. Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono costituiti o interposti solo sulla carta, senza una reale attività economica, la sanzione viene applicata direttamente alla persona fisica che ha agito dietro lo schermo societario.
Applicazione temporale delle nuove disposizioni
Il Testo Unico prevede un’applicazione differita. Sebbene pubblicato a novembre 2024 ed entrato formalmente in vigore il 29 novembre 2024, le disposizioni troveranno applicazione concreta soltanto dal primo gennaio 2026. Per le violazioni commesse tra settembre 2024 e dicembre 2025 continua ad applicarsi la disciplina del DLgs 87/2024.
Questo meccanismo di posticipazione dell’efficacia consente agli operatori di adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo. Consulenti fiscali, commercialisti e avvocati tributaristi hanno a disposizione un periodo di transizione per comprendere appieno le implicazioni operative della riforma e predisporre le necessarie strategie difensive.
Per le violazioni pregresse, commesse prima di settembre 2024, resta invece applicabile il “sistema binario” sopra descritto: responsabilità esclusiva per le società di capitali, solidarietà tra ente e autore dell’illecito per le società di persone e gli enti non riconosciuti.
Quando la solidarietà non è più automatica
Con la riforma introdotta dal 2024 cambia radicalmente il ruolo della responsabilità solidale. Non si tratta più di un principio generale applicabile a tutte le forme societarie prive di personalità giuridica sin dal momento dell’irrogazione della sanzione. La solidarietà viene ora circoscritta alla sola fase di riscossione.
Facciamo un esempio concreto. Una società in nome collettivo omette di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025. L’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2026, notifica l’avviso di accertamento irrogando la relativa sanzione. Quest’ultima viene contestata esclusivamente alla società, quale soggetto che risulta debitore del tributo. Solo successivamente, ove la società non adempia spontaneamente, l’Amministrazione finanziaria potrà attivare le procedure esecutive nei confronti dei singoli soci, secondo le regole civilistiche sulla responsabilità illimitata.
Il sistema così rimodellato cerca di coniugare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato rafforzare il principio di personalità della sanzione, concentrando la pretesa punitiva sul soggetto che ha realizzato materialmente l’attività economica violativa; dall’altro mantenere le garanzie patrimoniali necessarie all’Erario per assicurare l’effettivo recupero delle somme dovute.
La prova della società fittizia
Quando l’Amministrazione finanziaria intende contestare la natura fittizia di una società, deve fornire elementi probatori sufficienti. Non basta la mera sproporzione tra patrimonio sociale e operazioni dichiarate, né la coincidenza tra sede legale e domicilio del socio. Occorre dimostrare che la struttura societaria è stata creata artificiosamente, senza una reale autonomia decisionale e organizzativa, con il solo scopo di frapporsi tra il contribuente e il Fisco.
Nella prassi, gli indicatori di una società schermo possono essere molteplici: assenza di una struttura operativa effettiva, mancanza di dipendenti o collaboratori stabili, carenza di mezzi finanziari proporzionati all’attività svolta, coincidenza tra gli amministratori della controllante e quelli della controllata. Si consideri il caso di una Srl costituita da un professionista che continua a svolgere personalmente tutte le attività fatturate dalla società, senza alcuna organizzazione aziendale autonoma: l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la natura interposta della struttura.
Quando la fittizia costituzione viene accertata, le conseguenze sono pesanti. La sanzione colpisce direttamente il patrimonio della persona fisica che si è avvalsa dello schermo societario, venendo meno quella separazione patrimoniale che costituisce uno dei vantaggi principali nell’operare tramite una società. Si tratta di una forma di responsabilità personale che prescinde completamente dalla forma giuridica adottata.
Ricadute operative per professionisti e imprese
Le modifiche normative introdotte dal 2024 richiedono un ripensamento nelle strategie difensive. Gli amministratori di società di capitali possono contare su una maggiore protezione del proprio patrimonio personale, ma devono essere consapevoli che questa tutela viene meno qualora venga dimostrata la natura fittizia della struttura.
Per i soci di società di persone la situazione è più complessa. Sebbene la sanzione venga formalmente irrogata alla società, nella prassi il loro patrimonio personale resta esposto al rischio di aggressione da parte dell’Erario nella fase esecutiva. Occorre quindi prestare particolare attenzione alla corretta tenuta della contabilità sociale e alla puntuale osservanza degli obblighi dichiarativi e di versamento, poiché eventuali negligenze potrebbero ripercuotersi direttamente sulla sfera patrimoniale dei singoli.
I professionisti che assistono le imprese devono valutare attentamente la struttura societaria più idonea in relazione al rischio fiscale. Una società di capitali offre maggiore protezione ai soci, ma comporta oneri amministrativi e contabili più stringenti. Una società di persone consente maggiore flessibilità gestionale, ma espone i soci a responsabilità patrimoniale diretta.
La posizione della giurisprudenza tributaria
L’ordinanza della Cassazione n. 28888/2025 si inserisce in un orientamento consolidato. I giudici di legittimità hanno ribadito che il sistema binario – responsabilità esclusiva per le società di capitali, solidarietà per le società di persone – resta applicabile alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della riforma del settembre 2024.
Nel caso specifico esaminato, trattandosi di una società in accomandita semplice e di violazioni risalenti al 2008, trovava applicazione l’articolo 11 del DLgs 472/1997. La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che la sanzione dovesse gravare esclusivamente sul socio uscente, quando invece – secondo la disciplina vigente ratione temporis – l’Amministrazione finanziaria poteva legittimamente rivalersi anche sul patrimonio sociale.
La pronuncia offre spunti interessanti anche per quanto riguarda la successione temporale delle norme. Secondo quanto affermato dalla Cassazione, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento della commissione della violazione. Le modifiche legislative successive non producono effetti retroattivi, salvo che espressamente previsto. Ne deriva che per le violazioni pregresse continueranno ad applicarsi le vecchie regole, con conseguente stratificazione dei regimi sanzionatori.
Questioni ancora aperte
Nonostante il riordino operato dal Testo Unico, permangono alcune incertezze applicative. In particolare, resta da chiarire come operino le nuove disposizioni nei casi di trasformazione societaria. Se una società di persone viene trasformata in società di capitali, quale regime sanzionatorio si applica per le violazioni commesse prima della trasformazione? La questione potrebbe assumere rilievo nelle procedure di accertamento che investono periodi d’imposta in cui la forma giuridica della società era diversa dall’attuale.
Analogamente, si pone il problema della cessione d’azienda. Quando una società cede la propria azienda a un’altra, la responsabilità per le sanzioni fiscali pendenti segue il patrimonio ceduto oppure resta in capo al cedente? La risposta richiede un coordinamento tra le disposizioni del Testo Unico e quelle del codice civile in materia di trasferimento d’azienda, coordinamento che al momento presenta margini di incertezza.
Un’altra area di potenziale contenzioso riguarda la prova della fittizia costituzione. Il Testo Unico non fornisce criteri precisi per individuare quando una società debba considerarsi interposta. Sarà quindi la giurisprudenza, nei prossimi anni, a dover delineare gli elementi sintomatici della natura fittizia di una struttura societaria, bilanciando l’esigenza di contrastare l’elusione fiscale con quella di tutelare le legittime scelte organizzative degli imprenditori.