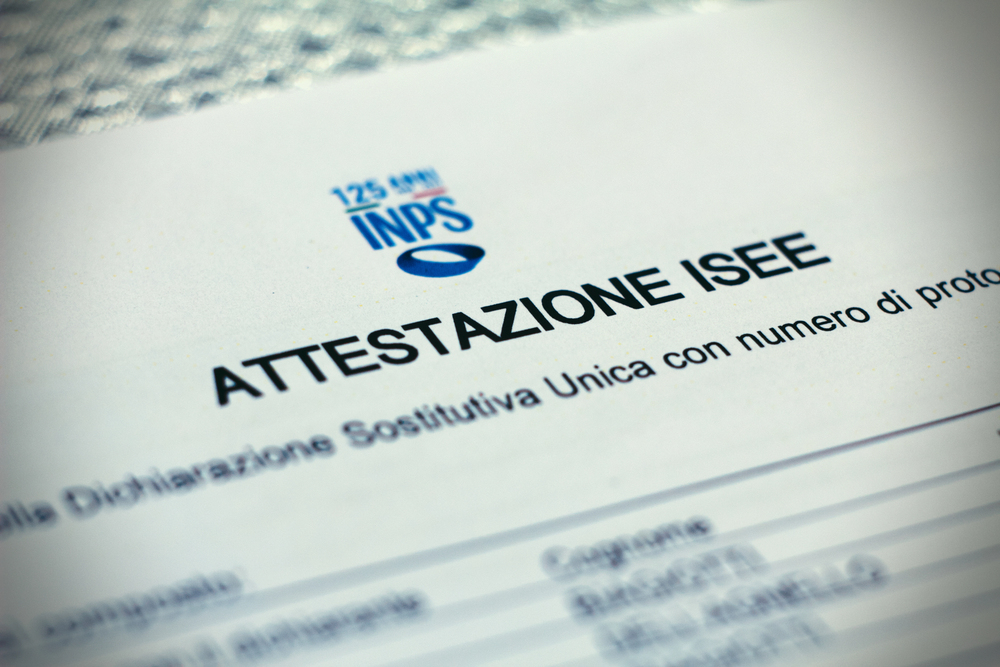L’annunciato innalzamento della soglia per l’abitazione principale nell’indicatore della situazione economica equivalente, contenuto nella bozza della manovra 2026, si traduce in un intervento che riguarderà una platea decisamente ristretta. L’analisi condotta dai Caf Acli su oltre 600.000 pratiche elaborate evidenzia come soltanto una famiglia su sette potrà effettivamente trarre vantaggio dalla misura, anche nella versione più generosa delle ipotesi circolate. La previsione di stanziare 500 milioni di euro annui per modificare il calcolo dell’ISEE, agendo sia sul valore della casa che sulle scale di equivalenza, assume dunque contorni diversi rispetto alla narrazione che ne è stata fatta nelle settimane scorse.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- L’innalzamento della franchigia prima casa ai fini ISEE (da 52.500 fino a 100.000 euro) riguarda circa il 15% dei nuclei, secondo dati Caf Acli.
- Quasi il 50% dei richiedenti ISEE hanno casa di proprietà, ma oltre metà di questi già ricadono nella franchigia attuale, quindi non avranno benefici.
- L’impatto reale sarà marginale per la maggior parte delle famiglie e non cambia molto le soglie di accesso ai bonus sociali.
- La riforma introduce anche nuove maggiorazioni sulla scala di equivalenza per famiglie con due o più figli, che potrebbe incidere maggiormente sull’ISEE.
- La misura si affianca all’esclusione di titoli di Stato e risparmio postale fino a 50.000 euro dal patrimonio mobiliare (norma in vigore da marzo 2025).
- Le nuove regole si applicano alle DSU presentate dal 1° gennaio 2026.
La fotografia del patrimonio abitativo italiano
Secondo quanto emerge dai dati raccolti dal network dei Caf Acli, appena il 49,5% dei nuclei che richiedono l’attestazione ISEE risulta proprietario dell’abitazione in cui vive. Parliamo quindi di una quota minoritaria, che già di per sé ridimensiona l’impatto potenziale di qualsiasi intervento sul valore catastale della prima casa. Ma c’è di più. All’interno di questo 49,5%, poco più della metà (il 51,5% per la precisione) presenta già oggi un valore catastale inferiore agli attuali 52.500 euro di franchigia. Per questi nuclei familiari, l’innalzamento della soglia – sia che si arrivi a 75.000 che a 100.000 euro – non produrrà alcun effetto pratico.
Restano quindi due fasce intermedie. La prima comprende quel 15,9% di proprietari con valori catastali compresi tra i 52.500 e i 75.000 euro. La seconda racchiude il 13,8% che si colloca tra i 75.000 e i 100.000 euro. Facendo le dovute proporzioni rispetto all’universo totale delle famiglie che presentano la DSU, emerge che con una soglia portata a 100.000 euro l’effettivo beneficio toccherebbe il 14,7% dei nuclei. Se invece la scelta dovesse ricadere sulla cifra intermedia di 75.000 euro, la percentuale scenderebbe ulteriormente al 7,9%. Numeri che ridimensionano parecchio la portata dell’intervento.
Come funziona oggi il calcolo per l’abitazione principale
Occorre ricordare che già nella normativa vigente, disciplinata dal Dpcm 159/2013, la casa di proprietà non viene considerata per intero ai fini ISEE. Esiste una franchigia di base pari a 52.500 euro, che sale di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Solo la parte eccedente questa soglia viene computata nel patrimonio, e comunque nella misura ridotta dei due terzi del suo valore. Il patrimonio complessivo (sia immobiliare che mobiliare) incide poi sul calcolo finale dell’indicatore soltanto per il 20%, mentre il restante 80% dipende dai redditi. Questo sistema di abbattimenti e franchigie fa sì che il peso specifico dell’abitazione sia già oggi piuttosto contenuto rispetto ad altri fattori.
Il valore catastale utilizzato per il calcolo si ottiene moltiplicando la rendita rivalutata del 5% per il coefficiente 160, arrivando così a cifre che sono generalmente molto inferiori ai valori di mercato. Per fare un esempio pratico: un immobile con rendita catastale di 625 euro genera un valore catastale di circa 105.000 euro (625 x 1,05 x 160), ma potrebbe valere sul mercato anche 300.000 o 400.000 euro, a seconda della zona e delle condizioni dell’immobile. È su questo valore fiscale, non su quello reale, che si applica la franchigia.
Le simulazioni sugli effetti concreti della riforma
I tecnici dei Caf Acli hanno elaborato alcune simulazioni per quantificare l’impatto effettivo sui nuclei familiari che rientrerebbero nel perimetro della riforma. Prendendo come riferimento una coppia con un figlio, reddito complessivo di 50.000 euro, patrimonio mobiliare di 80.000 euro e casa con valore catastale di 120.000 euro, l’innalzamento della soglia a 100.000 euro comporterebbe una riduzione dell’ISEE nell’ordine del 9%. Se la soglia si fermasse a 75.000 euro, la diminuzione scenderebbe al 7,5%. Percentuali che, per quanto apprezzabili per le famiglie interessate, non configurano certo rivoluzioni nel sistema di accesso alle prestazioni sociali.
Si consideri inoltre che molte delle prestazioni agevolate legate all’ISEE prevedono soglie di accesso piuttosto basse, collocate tra i 15.000 e i 25.000 euro. Per una famiglia che oggi si trova con un ISEE di 30.000 euro, una riduzione anche del 9% la porterebbe a circa 27.300 euro, lasciandola comunque fuori dalla maggior parte dei benefici. L’effetto pratico si avvertirebbe principalmente per chi si colloca appena sopra le soglie di accesso ai vari bonus, creando quello che nella prassi amministrativa viene definito un “effetto margine”.
Il nodo della scala di equivalenza
Accanto all’intervento sul valore della casa, la bozza di manovra prevede modifiche anche ai coefficienti della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli. Attualmente, la scala parte da 1 per il primo componente, aggiunge 0,57 per il secondo, 0,47 per il terzo e così via. Sono previste maggiorazioni dello 0,35 per ogni figlio minorenne successivo al secondo, che salgono allo 0,5 se i figli sono almeno tre e tutti minorenni. L’ipotesi allo studio prevede un rafforzamento di questi coefficienti, andando a ridurre l’ISEE finale per le famiglie numerose.
Questa parte della riforma appare, almeno in teoria, più incisiva rispetto all’intervento sulla casa. Le maggiorazioni sulla scala di equivalenza agiscono infatti come divisori del valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), producendo effetti percentuali più marcati. Una famiglia con tre figli potrebbe vedere il proprio indicatore calare in misura più significativa rispetto alla sola esclusione parziale del valore dell’abitazione. Resta però da capire quale sarà l’entità concreta degli aumenti proposti e come si coordineranno con l’Assegno Unico, che già oggi prevede importi crescenti per i nuclei più numerosi.
Titoli di Stato e risparmio postale: il precedente
La riforma dell’ISEE per il 2026 si inserisce in un percorso già avviato lo scorso anno. Dal 3 aprile 2025 sono operative le disposizioni che escludono dal patrimonio mobiliare i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare. Il Dpcm 14 gennaio 2025 n. 13, entrato in vigore il 5 marzo, ha dato attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2024. Chi aveva già presentato la DSU nei primi mesi del 2025 ha potuto rifare il calcolo applicando i nuovi criteri, se più favorevoli.
L’esclusione dei titoli di Stato risponde alla logica di non penalizzare forme di risparmio garantite dallo Stato, considerate una forma di tutela patrimoniale delle famiglie piuttosto che un indicatore di ricchezza effettiva. Analoga filosofia ispira l’intervento sulla prima casa: riconoscere che l’abitazione principale non costituisce un bene liquido o un elemento di capacità contributiva immediata, ma rappresenta piuttosto il risultato di risparmi accumulati nel tempo, spesso attraverso mutui pluridecennali.
I vincoli di bilancio e le soglie di reddito
Lo stanziamento previsto si attesta su 500 milioni di euro annui, una cifra che in termini di finanza pubblica non consente interventi a pioggia. Di qui la necessità di individuare tetti e paletti per circoscrivere la platea dei beneficiari. Secondo quanto trapelato nelle settimane precedenti all’approvazione della bozza, il governo starebbe valutando l’introduzione di soglie di reddito oltre le quali l’esclusione della casa non opererebbe. In altre parole, anche se il valore catastale rientra nei limiti previsti, nuclei con redditi superiori a determinate fasce potrebbero non beneficiare dell’alleggerimento.
Questo meccanismo di doppio filtro (valore catastale + reddito) risponde all’esigenza di concentrare le risorse sulle famiglie effettivamente in difficoltà, evitando che l’agevolazione vada a favore di chi presenta redditi elevati ma possiede un’abitazione dal valore catastale contenuto. Nella pratica operativa dei Caf, non è raro incontrare situazioni di questo tipo: professionisti con guadagni rilevanti che abitano in immobili con rendite catastali modeste, magari ereditati o acquistati in zone periferiche dove i valori catastali sono rimasti fermi a parametri datati.
Criticità applicative e prospettive operative
L’entrata in vigore della riforma richiederà la presentazione di nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche a partire dal 1° gennaio 2026. L’INPS dovrà aggiornare i propri sistemi informatici e la modulistica, così come avvenuto ad aprile 2025 per l’esclusione dei titoli di Stato. I Caf e gli altri intermediari abilitati dovranno formare il personale sulle nuove regole, con particolare attenzione ai casi limite e alle situazioni che potrebbero generare contenziosi. Si pensi ad esempio alle famiglie proprietarie di immobili con valori catastali prossimi alle soglie, o a quelle con composizioni del nucleo familiare particolari.
Un aspetto spesso trascurato riguarda il possibile effetto distorsivo sulle scelte abitative delle famiglie. Se l’esclusione opera solo fino a un determinato valore, potrebbe crearsi un disincentivo all’acquisto o al possesso di immobili che superino quella soglia, almeno per chi è vicino ai limiti di accesso a prestazioni agevolate. Fenomeni di questo tipo sono già stati osservati con altre misure vincolate all’ISEE, come l’Assegno Unico o le borse di studio universitarie, dove spostarsi di pochi euro può significare la perdita di benefici anche consistenti.
L’impatto sul sistema del welfare
Le prestazioni sociali che fanno riferimento all’ISEE sono numerose e eterogenee. Si va dall’Assegno di Inclusione ai bonus per le utenze domestiche (elettricità, gas, acqua), dalle agevolazioni per le mense scolastiche alle riduzioni delle tasse universitarie, dai contributi per gli asili nido agli aiuti per l’acquisto di libri di testo. Ogni misura ha proprie soglie di accesso e propri meccanismi di calcolo dell’importo spettante. Una riduzione anche contenuta dell’ISEE può quindi aprire nuove opportunità per alcune famiglie, ma l’effetto complessivo dipenderà dalla collocazione iniziale del singolo nucleo rispetto alle varie soglie.
Nella casistica quotidiana degli operatori dei Caf emerge spesso la frustrazione di famiglie che si vedono escluse da benefici per differenze minime di indicatore. Il sistema attuale, basato su soglie rigide, genera inevitabilmente situazioni di questo tipo. La riforma, pur con i suoi limiti quantitativi, potrebbe almeno in parte attenuare questo fenomeno per quella fascia di famiglie proprietarie della casa che oggi si colloca appena sopra le soglie di accesso. Resta però il fatto che l’85% dei richiedenti ISEE, secondo le proiezioni elaborate, non vedrà alcun cambiamento nella propria situazione.
Questioni aperte sul fronte catastale
L’utilizzo del valore catastale come parametro di riferimento solleva questioni che vanno oltre il calcolo dell’ISEE. Il sistema catastale italiano è notoriamente obsoleto, con rendite che in molti casi risalgono agli anni Settanta o Ottanta e che non riflettono minimamente i valori di mercato attuali. Ampie zone del Paese presentano disparità evidenti, con immobili simili classificati in categorie diverse o con rendite profondamente differenti. Ogni riforma che si appoggi su questi valori eredita inevitabilmente tutte le distorsioni del sistema.
Il Governo ha più volte annunciato una revisione del catasto, ma i tempi tecnici e politici appaiono ancora lunghi. Nel frattempo, l’esclusione della prima casa fino a 100.000 euro di valore catastale assume significati molto diversi a seconda del territorio. In alcune aree metropolitane, quel valore può corrispondere a piccoli appartamenti in zone semicentrali. In comuni di provincia o in aree interne, può rappresentare anche villette unifamiliari di discrete dimensioni. L’uniformità della soglia nazionale non tiene conto di queste difformità, replicando sul piano dell’ISEE disuguaglianze che hanno origine altrove.