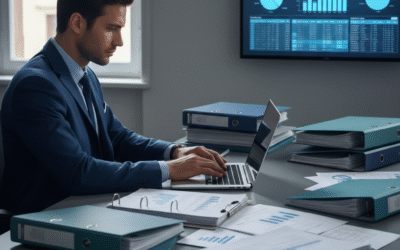Chi opera nel regime forfettario può dedurre dal proprio reddito imponibile esclusivamente i contributi previdenziali che la legge impone di versare. Niente da fare per i versamenti volontari o per quelli destinati a forme pensionistiche integrative. Una distinzione che nella pratica crea non pochi dubbi tra i professionisti, soprattutto quando si tratta di capire quali somme possono effettivamente ridurre la base su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15 per cento.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Solo i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili per i forfettari.
- Sono esclusi: versamenti volontari, previdenza integrativa, riscatto laurea e fondi pensione.
- Sono deducibili i versamenti dovuti alle casse professionali, Gestione Separata INPS e gestioni artigiani/commercianti.
- Attenzione ai contributi per collaboratori: deducibili solo se obbligatori e realmente versati.
- L’Agenzia delle Entrate ribadisce la deducibilità solo per somme dovute per legge.
- L’eccedenza di contributi può essere recuperata secondo specifiche regole.
- Prestare attenzione a non dedurre contributi non ammessi in dichiarazione.
La regola generale sui contributi deducibili
Il meccanismo previsto per i forfettari è abbastanza lineare, almeno sulla carta. Si possono portare in deduzione unicamente i contributi che hanno carattere di obbligatorietà, vale a dire quelli che il contribuente deve versare per legge alla propria gestione previdenziale. Restano fuori tutti gli altri, e qui la casistica si fa più articolata di quanto sembri a prima vista.
Capita spesso che professionisti o artigiani decidano di integrare la propria posizione previdenziale con versamenti aggiuntivi, magari rivolgendosi a fondi pensione o cassette di previdenza complementare. Questi contributi, pur essendo deducibili in altri regimi fiscali, non lo sono per chi ha optato per il forfettario. Stesso discorso vale per il riscatto della laurea o per i contributi finalizzati a ottenere benefici ai fini Irpef.
Quali versamenti si possono dedurre
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190/2014, la deduzione spetta soltanto per i contributi obbligatori. Ma cosa significa esattamente “obbligatori”? Nella prassi applicativa si considerano tali i versamenti dovuti alle casse professionali, alla gestione separata Inps per i collaboratori, o alle gestioni artigiani e commercianti. Insomma, tutto ciò che la normativa impone di pagare.
Un caso particolare riguarda i contributi previdenziali versati per i collaboratori dell’impresa familiare. Questi sono deducibili, ma occorre che siano effettivamente a carico del titolare e che riguardino collaboratori iscritti a libro paga. Non basta l’iscrizione formale, deve esserci un rapporto sostanziale con versamenti realmente effettuati. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo questa possibilità, proprio per evitare abusi.
L’eccedenza di contributi versati
Può capitare che nel corso dell’anno un contribuente versi all’Inps somme superiori a quelle effettivamente dovute. Questo accade, ad esempio, quando si paga in acconto un importo stimato che poi si rivela eccessivo rispetto al reddito conseguito. In questi casi l’eccedenza può essere recuperata, ma con modalità diverse a seconda della finalità per cui era stata versata.
Se i contributi erano destinati alla propria posizione previdenziale, l’eccedenza resta nel calcolo della pensione futura. Se invece erano stati versati per ottenere una deduzione Irpef (cosa che può accadere in situazioni particolari), allora si apre la strada al rimborso o alla compensazione. Bisogna valutare caso per caso, perché la normativa non è sempre cristallina su questo punto.
Come si calcolano i contributi dovuti
Per i forfettari la determinazione dell’ammontare dei contributi previdenziali da versare segue regole specifiche. Chi è iscritto alla gestione artigiani o commercianti, oppure alla gestione separata, beneficia di un meccanismo agevolato che riduce la base imponibile su cui calcolare i contributi. Tecnicamente si applica un abbattimento, che per il 2024 era del 35 per cento.
L’articolo 28 del decreto legislativo n. 98 del 2011 aveva già introdotto questo meccanismo, poi confermato e modificato nel tempo. Per il 2025 la situazione si è fatta più articolata, perché la legge di bilancio ha previsto un incentivo ulteriore per i contribuenti under 35 al primo anno di attività. In pratica chi rientra in questa categoria può beneficiare di una riduzione ancora maggiore, che arriva al 50 per cento per i primi trentasei mesi.
Si tratta di una misura pensata per agevolare l’avvio di nuove attività, ma che presenta profili applicativi non del tutto chiari. Alcuni commercialisti segnalano difficoltà nell’interpretare chi possa effettivamente accedervi, soprattutto nei casi in cui il contribuente abbia già avuto in passato altre partite Iva.
Gestione separata e contributi per collaboratori
Chi lavora come consulente o freelance spesso è iscritto alla gestione separata Inps. Per questi soggetti la deducibilità opera sui contributi versati sia in proprio che, eventualmente, per collaboratori a progetto o figure assimilate. La norma prevede che anche i contributi versati dal committente siano deducibili, ma solo nella misura in cui gravano effettivamente sul reddito del forfettario.
Nella pratica professionale si osserva che molti contribuenti confondono i contributi versati in nome proprio con quelli che riguardano eventuali collaboratori dell’impresa. È opportuno tenere distinte queste voci, perché hanno trattamenti diversi ai fini della deduzione. Per i collaboratori familiari, ad esempio, occorre verificare che non siano a carico ma che abbiano un’autonoma posizione contributiva.
Casse professionali e previdenza complementare
I professionisti iscritti a casse private (avvocati, ingegneri, medici e altre categorie) possono dedurre i soli contributi obbligatori versati alla propria cassa. Questo significa che vanno esclusi i contributi integrativi o volontari, anche se la cassa li prevede come opzione.
C’è poi il tema dei fondi pensione, che nella fiscalità ordinaria godono di deducibilità fino a 5.164,57 euro annui. Per i forfettari questa possibilità non esiste: il versamento a fondi complementari resta completamente indeducibile, non incide in alcun modo sulla determinazione del reddito imponibile. Una differenza di trattamento che alcuni ritengono penalizzante, ma che deriva dalla natura stessa del regime forfettario, pensato per semplificare al massimo gli adempimenti.
Le verifiche da fare in dichiarazione
Quando si compila la dichiarazione dei redditi occorre prestare attenzione alla corretta indicazione dei contributi deducibili. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 77, della legge n. 190/2014, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di versamenti effettuati. Un errore frequente consiste nel dedurre anche contributi che non hanno natura obbligatoria, magari perché versati volontariamente per migliorare la propria posizione pensionistica.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni, attraverso circolari e risposte a interpelli, che la deduzione spetta esclusivamente per i contributi dovuti per legge. Questo principio vale anche quando il contribuente scelga di versare anticipatamente somme che poi risulteranno eccedenti rispetto al dovuto. In quel caso si applica la disciplina dell’eccedenza, che può portare o meno a un rimborso.
Riscatto laurea e altri contributi volontari
Il riscatto del periodo di studi universitari rappresenta una facoltà che consente di valorizzare ai fini pensionistici gli anni trascorsi all’università. Per chi è in regime forfettario, tuttavia, i contributi versati per il riscatto non sono deducibili. Questo vale sia per il riscatto ordinario che per quello agevolato, introdotto per i periodi successivi al 1996.
Anche altri tipi di contributi volontari, come quelli versati per coprire periodi di interruzione dell’attività o per aumentare l’anzianità contributiva, non possono essere portati in deduzione. La logica del regime forfettario è quella di limitare le deduzioni al minimo indispensabile, concentrandosi sui soli costi strutturali e obbligatori.
Aspetti operativi e criticità ricorrenti
Nell’esperienza applicativa emergono spesso dubbi su situazioni particolari. Ad esempio, cosa succede quando un forfettario versa contributi per un collaboratore che poi cessa l’attività prima della fine dell’anno? O quando i contributi vengono versati con ritardo, magari nell’anno successivo a quello di competenza?
La prassi amministrativa suggerisce di considerare deducibili i contributi nell’anno in cui sarebbero dovuti, anche se versati in ritardo. Tuttavia questo principio non sempre trova applicazione uniforme, e capita che l’Agenzia delle Entrate contesti deduzioni operate in anni diversi da quelli di competenza. Si tratta di aspetti spesso trascurati che però possono avere conseguenze rilevanti in sede di controllo.
Un altro punto critico riguarda la certificazione dei contributi versati. Alcune casse professionali rilasciano certificazioni che includono anche quote integrative o volontarie, senza distinguerle chiaramente da quelle obbligatorie. Il contribuente deve essere in grado di operare questa distinzione autonomamente, altrimenti rischia di dedurre importi non spettanti.
Prospettive applicative
La disciplina dei contributi deducibili per i forfettari resta un terreno su cui la normativa potrebbe evolversi nei prossimi anni. Alcune forze politiche hanno proposto di estendere la deducibilità anche ai contributi previdenziali complementari, almeno entro certi limiti, per allineare il trattamento a quello degli altri regimi fiscali.
Al momento però la situazione è quella descritta: si deducono solo i contributi obbligatori, punto. Chi opera in regime forfettario deve tenerne conto nella pianificazione fiscale, evitando di fare affidamento su deduzioni che poi non risultano ammesse. La semplicità del regime si paga anche con qualche limitazione, e questa è certamente una delle più significative.