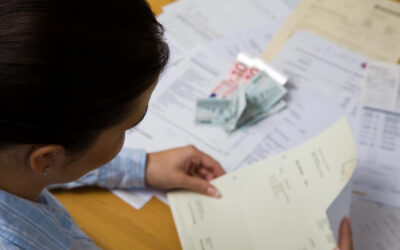La recente sentenza n. 8716/2025 della Suprema Corte ha fornito nuova linfa al consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue tra operazioni soggettivamente inesistenti e quelle oggettivamente inesistenti, confermando parametri di valutazione ormai cristallizzati nella prassi giudiziaria tributaria. Una distinzione tutt’altro che meramente teorica, che nella pratica professionale incide pesantemente sulle scelte strategiche dei contribuenti e dei loro consulenti. La pronuncia si inserisce, come spesso accade in ambito tributario, in una linea evolutiva che trova le sue radici in precedenti consolidati – segnatamente le sentenze n. 8480/2022 e n. 4645/2020 – ampliando però il raggio d’azione e fornendo elementi di chiarezza su aspetti che talvolta generavano perplessità applicative.
Il discrimine tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni
La giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che le operazioni oggettivamente inesistenti comportano l’esclusione automatica della deducibilità fiscale. Tale esclusione opera indipendentemente dalla conformità formale ai requisiti previsti dall’articolo 109 del TUIR e dall’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 per IRES e IRAP.
Il fondamento di questa rigida preclusione risiede nella natura stessa dell’operazione: mancando qualsiasi riscontro concreto nella realtà economica, viene meno il presupposto sostanziale che giustifica la deduzione fiscale. Si consideri che la giurisprudenza ha sempre sostenuto come la mera apparenza formale non possa legittimare fiscalmente costi privi di effettivo substrato economico.
Ben diversa la disciplina riservata alle operazioni soggettivamente inesistenti, caratterizzate dalla presenza di un’attività economica concreta, seppur documentata con fatture emesse da soggetti formalmente non abilitati o inesistenti. Nella casistica comune rientrano le società “cartiere” o gli intermediari fittizi, situazioni nelle quali l’operazione commerciale ha effettivamente avuto luogo, ma attraverso una documentazione fiscale viziata sotto il profilo soggettivo.
Requisiti per la deducibilità nelle operazioni soggettivamente inesistenti
L’ammissibilità della deduzione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti rimane subordinata alla rigorosa dimostrazione dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa tributaria. Come spesso accade nella pratica professionale, è necessario verificare il rispetto dei principi di effettività, inerenza e certezza dell’operazione economica sottostante.
L’effettività dell’operazione si traduce nella reale esecuzione del fatto economico, requisito che deve essere dimostrato attraverso documentazione probatoria adeguata – contratti, corrispondenza commerciale, movimentazioni bancarie, consegne materiali. L’esperienza applicativa dimostra come questo aspetto costituisca spesso il punto più delicato della verifica fiscale.
L’inerenza richiede un collegamento diretto e funzionale tra il costo sostenuto e l’attività d’impresa. Si tratta di un parametro che la giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo rigoroso, richiedendo non solo la generica attinenza all’attività sociale, ma un nesso causale specifico e documentabile.
La competenza economica impone l’imputazione del costo al periodo d’imposta corretto, evitando artifici contabili che potrebbero configurare manovre elusive. Secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, è necessario rispettare il principio di correlazione temporale tra sostenimento del costo e sua rilevazione fiscale.
Il sistema probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti
Nell’esperienza applicativa emerge chiaramente come l’onere probatorio rappresenti l’elemento cruciale per il disconoscimento dei costi. La Cassazione ha infatti precisato che per contestare la deducibilità di fatture soggettivamente inesistenti non è sufficiente dimostrare la fittizietà del fornitore, ma occorre anche provare la consapevolezza del contribuente del disegno fraudolento.
Ai sensi dell’orientamento consolidato (tra le altre, Cassazione n. 15005/2020 e n. 9851/2018), l’Amministrazione deve fornire elementi probatori, anche presuntivi, che dimostrino come il contribuente fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza professionale – della sostanziale inesistenza del contraente.
Tale approccio si fonda sul principio secondo cui la mera irregolarità formale o soggettiva, pur rilevante dal punto di vista fiscale, non determina automaticamente la negazione del diritto alla deduzione qualora siano stati sostenuti costi reali e inerenti all’attività economica.
Le modifiche normative del decreto legge n. 16/2012
È opportuno notare come l’evoluzione giurisprudenziale si innesti su un quadro normativo modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44). L’articolo 8, comma 1, di tale decreto ha infatti riconosciuto espressamente la deducibilità dei costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, operando con efficacia retroattiva in bonam partem.
La disposizione normativa ha così cristallizzato un orientamento che la giurisprudenza andava consolidando, eliminando incertezze interpretative che spesso si traducevano in contenziosi prolungati. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 32/E/2012), tale modifica ha comportato che “l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fattura che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Aspetti spesso trascurati nella prassi applicativa
Nella casistica comune si osserva come la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva assuma rilievo concreto soprattutto nelle verifiche fiscali relative a operazioni triangolari o a catene di subfornitura. In tali contesti, la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività economica diventa elemento discriminante per preservare la deducibilità dei costi.
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la tempistica della prova: mentre l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni per dimostrare la fittizietà del rapporto, il contribuente deve fornire elementi probatori positivi e specifici per confermare l’effettivo svolgimento dell’operazione.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che rimane esclusa la deducibilità qualora i beni o servizi siano stati “direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (articolo 8, comma 1, D.L. 16/2012). Tale limitazione opera indipendentemente dalla natura soggettiva dell’inesistenza, richiedendo una valutazione caso per caso della finalizzazione delittuosa.
Criticità ricorrenti e orientamenti di prassi
Nell’esperienza professionale si rileva come la distinzione tra le due tipologie di inesistenza possa talvolta risultare sfumata, soprattutto in presenza di operazioni complesse che coinvolgono più soggetti. La Suprema Corte ha tuttavia fornito parametri di riferimento chiari: ciò che rileva è la sussistenza di un effettivo scambio economico, indipendentemente dalle irregolarità documentali o soggettive.
Un elemento di criticità ricorrente riguarda la valutazione della consapevolezza del contribuente nel disegno fraudolento. La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva che tenga conto della qualità professionale del soggetto, delle modalità operative adottate e degli elementi di contesto che potevano far sorgere dubbi sulla genuinità dell’operazione.
Si deve inoltre considerare che l’orientamento consolidato non rappresenta un’innovazione assoluta, ma si colloca in continuità con una linea interpretativa che ha progressivamente affinato i criteri di valutazione della sostanza delle operazioni economiche nei rapporti tributari.