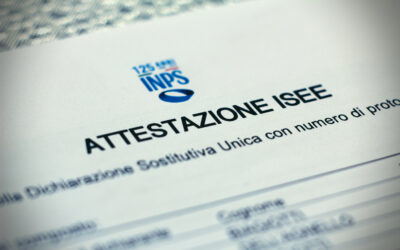La Corte costituzionale, attraverso la pronuncia n. 118 del luglio 2025, ha ridefinito radicalmente il quadro normativo applicabile ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, dichiarando incostituzionale il limite massimo di sei mensilità previsto dal Jobs Act. Una decisione che segna una frattura netta con il precedente regime sanzionatorio, modificando sostanzialmente gli equilibri contrattuali tra datori di lavoro di dimensioni ridotte e dipendenti.
La sentenza interviene su una delle disposizioni più controverse del Decreto legislativo n. 23 del 2015, specificamente l’articolo 9, comma 1, eliminando quella che la Consulta ha definito come una tutela «circoscritta entro una forbice così esigua» da risultare inadeguata rispetto ai principi costituzionali.
Il quadro normativo precedente alla decisione
Prima dell’intervento della Corte costituzionale, il sistema introdotto dal Jobs Act prevedeva un trattamento differenziato per le aziende sotto soglia – quelle che non occupano più di 15 dipendenti per unità produttiva o 60 complessivamente. Per questi datori di lavoro, il licenziamento illegittimo comportava un’indennità risarcitoria che, nella prassi giurisdizionale, si attestava su valori significativamente inferiori rispetto alle imprese maggiori.
Il meccanismo sanzionatorio si articolava su due livelli distinti: da un lato, il dimezzamento delle indennità rispetto a quelle spettanti ai lavoratori delle aziende sopra soglia; dall’altro, l’imposizione di un tetto invalicabile di sei mensilità. Questo doppio vincolo creava una situazione in cui l’indennizzo si collocava, nella maggior parte dei casi, tra le 2,5 e le 6 mensilità, con scarsa possibilità di personalizzazione da parte del giudice.
Nel dettaglio, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 presso datori di lavoro sottosoglia, la disciplina distingueva tra:
- Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo: indennizzo pari a 1 mensilità per anno di servizio, con minimo di 2 mensilità e massimo di 6
- Violazioni procedurali o di motivazione: indennizzo pari a mezza mensilità per anno di servizio, con minimo di 1 mensilità e massimo comunque di 6
Le argomentazioni della Corte costituzionale
La Consulta ha sviluppato un ragionamento articolato che tocca diversi profili costituzionali. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il limite fisso e insuperabile impedisce al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante se si considera che la giurisprudenza di legittimità aveva già indicato, in precedenti pronunce, la necessità di un’indennità che sia proporzionata al danno effettivamente subito dal lavoratore.
La sentenza n. 118 del 2025 richiama espressamente i precedenti orientamenti (in particolare la sentenza n. 183 del 2022), sottolineando come l’inerzia del legislatore abbia reso necessario un intervento diretto della Corte. In quella precedente pronuncia, la Consulta aveva già segnalato l’incostituzionalità latente della norma, auspicando un intervento correttivo che non si è mai materializzato.
Sul piano dell’uguaglianza sostanziale, la Corte ha evidenziato come la disparità di trattamento tra lavoratori delle piccole e grandi imprese non trovi più giustificazione costituzionale quando l’indennità risulti così compressa da non svolgere nemmeno la funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro. Questo aspetto assume particolare rilievo se si considera che, secondo i dati ISTAT richiamati nel giudizio, la disciplina riguarda la quasi totalità delle imprese italiane e una parte significativa della forza lavoro.
Profili di criticità nella precedente disciplina
L’analisi della Corte ha messo in evidenza diverse criticità del sistema previgente che, nella casistica quotidiana, si manifestavano attraverso disparità di trattamento difficilmente giustificabili. Un licenziamento discriminatorio o disciplinarmente infondato, a parità di gravità e di danno causato al lavoratore, comportava conseguenze economiche radicalmente diverse a seconda che l’azienda avesse 14 o 16 dipendenti.
La rigidità del tetto massimo creava situazioni paradossali: un lavoratore con elevata anzianità di servizio, licenziato senza giusta causa da una piccola impresa, poteva ricevere un indennizzo inferiore a quello spettante a un collega con minore anzianità impiegato presso un’azienda di maggiori dimensioni. Questa disparità, che nella prassi si verificava frequentemente, ha rappresentato uno degli elementi decisivi per l’intervento della Consulta.
Inoltre, il criterio esclusivamente numerico (numero di dipendenti) per determinare la capacità economica dell’impresa appariva sempre più anacronistico. Come osservato dalla Corte, nella legislazione europea e nazionale di altri settori – si pensi alla disciplina della crisi d’impresa – il solo parametro occupazionale non costituisce l’indicatore esclusivo della forza economica aziendale.
Gli effetti immediati della sentenza
La dichiarazione di incostituzionalità comporta la disapplicazione immediata del limite delle sei mensilità per tutti i procedimenti in corso e futuri. Tuttavia, è opportuno precisare che la sentenza non elimina completamente la disciplina differenziata per le piccole imprese: rimane in vigore il meccanismo del dimezzamento delle indennità rispetto a quelle previste per le aziende sopra soglia.
In concreto, questo significa che i giudici dovranno ora determinare l’indennità considerando diversi parametri – anzianità lavorativa, danno effettivamente subito, comportamento delle parti, gravità del vizio – senza essere vincolati dal tetto fisso. L’indennizzo potrà quindi superare le sei mensilità quando la specificità del caso lo richieda, pur rimanendo dimezzato rispetto agli importi previsti per le grandi imprese.
Questa nuova impostazione richiederà inevitabilmente una maggiore accuratezza nella preparazione delle cause da parte dei legali, che dovranno fornire al giudice elementi probatori puntuali per giustificare un indennizzo superiore alle tradizionali sei mensilità. Si prevede, di conseguenza, un aumento della durata media dei procedimenti e della loro complessità istruttoria.
Ripercussioni per le piccole imprese
Dal punto di vista delle imprese, la decisione introduce un elemento di incertezza significativo. Il rischio economico associato ai licenziamenti illegittimi diventa più difficile da quantificare ex ante, rendendo necessaria una maggiore cautela nella gestione del potere disciplinare e nelle procedure di recesso.
Le organizzazioni datoriali hanno manifestato preoccupazione per l’impatto della sentenza, sottolineando come molte microimprese operino con margini ridottissimi e liquidità limitata. Un incremento sostanziale degli indennizzi potrebbe, secondo questa prospettiva, scoraggiare le assunzioni o spingere verso forme contrattuali più precarie.
Tuttavia, è importante osservare che la sentenza non comporta automaticamente un aumento generalizzato degli indennizzi. La personalizzazione della tutela significa che licenziamenti effettuati nel rispetto delle garanzie procedurali e con motivazioni adeguate continueranno probabilmente a comportare indennizzi contenuti, mentre quelli caratterizzati da gravi irregolarità o discriminazioni potranno essere sanzionati più severamente.
Prospettive applicative e questioni aperte
La pronuncia della Consulta apre numerose questioni interpretative che la giurisprudenza di merito dovrà affrontare nei prossimi mesi. In primo luogo, sarà necessario definire i criteri per determinare quando un indennizzo possa superare le sei mensilità, evitando al contempo disparità territoriali eccessive.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la quantificazione del danno effettivamente subito dal lavoratore. La Corte ha sottolineato l’importanza della personalizzazione, ma ha lasciato ai giudici il compito di individuare i parametri concreti per questa valutazione. È probabile che si sviluppi una casistica differenziata a seconda del tipo di vizio (discriminatorio, procedurale, sostanziale) e delle circostanze specifiche.
La sentenza solleva inoltre interrogativi sulla sostenibilità del sistema per le microimprese più fragili. Se è vero che la tutela costituzionale del lavoro non può essere compressa oltre certi limiti, è altrettanto vero che un eccesso di rigidità sanzionatoria potrebbe produrre effetti controproducenti sull’occupazione nelle realtà di minori dimensioni.
Auspici per un intervento legislativo
La Corte costituzionale ha espresso chiaramente l’auspicio di un intervento legislativo che riveda complessivamente la disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese. La pronuncia suggerisce di superare il criterio esclusivamente numerico, orientandosi verso parametri che tengano conto della reale capacità economica delle aziende.
In questa prospettiva, potrebbero essere considerati indicatori integrativi come il fatturato, la struttura patrimoniale, il settore di attività, la forma giuridica dell’impresa. Un approccio più sofisticato consentirebbe di mantenere un regime differenziato per le realtà effettivamente fragili, senza penalizzare eccessivamente i lavoratori.
Inoltre, il legislatore potrebbe valutare l’introduzione di meccanismi di gradualità nella determinazione dell’indennità, prevedendo fasce di tutela progressive in base alla combinazione di diversi parametri economici e dimensionali. Questo approccio, già sperimentato in altri ordinamenti europei, potrebbe garantire un migliore bilanciamento tra tutela del lavoro e sostenibilità per le imprese.
La questione non è meramente tecnica, ma tocca questioni fondamentali del nostro sistema economico e sociale. La necessità di coniugare la protezione costituzionale del lavoro con la realtà del tessuto produttivo italiano – caratterizzato da una prevalenza schiacciante di piccole e microimprese – richiede soluzioni normative innovative e bilanciate.