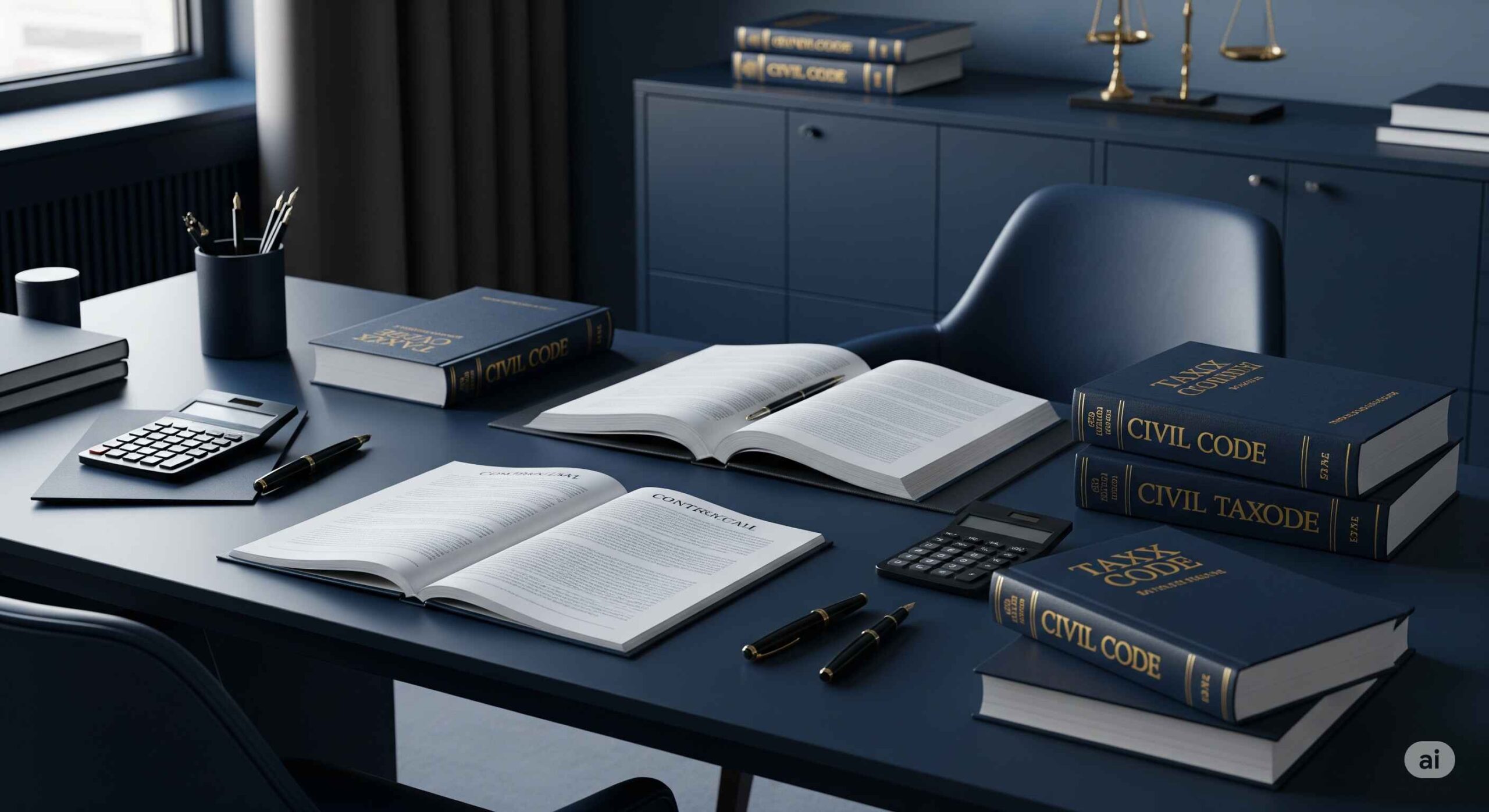L’affitto d’azienda, sul piano civilistico, non ha una disciplina unitaria. Eppure, sul piano fiscale, da una clausola spesso trascurata dipende un effetto molto concreto: chi deduce le quote di ammortamento dei beni compresi nel complesso aziendale. Tutto ruota attorno al richiamo o meno, nel contratto, dell’articolo 2561 c.c. e al combinato disposto con l’articolo 102, comma 8, del TUIR. A seconda di come si scrive l’accordo, cambia il soggetto che ammortizza: affittuario oppure concedente. E, in certe ipotesi, la deduzione può sparire del tutto, restando solo come minore plusvalenza in caso di futura cessione.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- L’affitto di azienda non ha una disciplina organica nel codice civile: si ricostruisce tra affitto, usufrutto e cessione di azienda.
- Se il contratto richiama l’art. 2561 c.c., l’affittuario deve mantenere l’azienda efficiente e può dedurre le quote di ammortamento.
- La deduzione avviene ai sensi dell’art. 102, comma 8, TUIR, sul costo originario e sul residuo non ammortizzato risultante dalla contabilità del locatore.
- L’affittuario deve tenere un proprio registro dei beni ammortizzabili, anche mediante le semplificazioni su libro inventari o registro IVA acquisti.
- La disciplina si estende anche ai beni immateriali, in base al collegamento tra artt. 103 e 108 TUIR.
- Se il contratto deroga all’art. 2561 c.c. e la manutenzione resta in capo al locatore, gli ammortamenti sono deducibili dal locatore stesso, se ancora imprenditore.
- Se l’imprenditore affitta l’unica azienda e perde la qualifica di imprenditore, i canoni sono redditi diversi (art. 67 TUIR) e non sono deducibili ammortamenti.
- Il deperimento dei beni in questo ultimo caso rileva solo in sede di futura cessione, come minor plusvalenza o maggiore minusvalenza.
- La corretta formulazione delle clausole su manutenzione e richiamo dell’art. 2561 c.c. è decisiva per allocare il beneficio fiscale degli ammortamenti.
1
Il fitto d’azienda tra codice civile e prassi contrattuale
Nel codice civile non esiste un corpo organico di norme dedicato all’affitto di azienda. La disciplina va ricostruita combinando le regole generali sull’affitto, quelle sull’usufrutto di azienda e quelle sulla cessione di azienda.
Nella prassi, quindi, il contratto di affitto d’azienda è un “ibrido” costruito dai contraenti, che pescano di volta in volta negli articoli più funzionali.
Il punto di contatto più rilevante, per il tema che interessa qui, è l’articolo 2561 c.c. sull’usufrutto di azienda.
L’articolo 2561 c.c.: la clausola che cambia il regime fiscale
L’articolo 2561, comma 2, c.c. stabilisce che l’usufruttuario deve:
- gestire l’azienda senza modificarne la destinazione
- conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti
- mantenere le normali dotazioni di scorte
Se non rispetta questi obblighi, oppure interrompe arbitrariamente la gestione, si applica l’articolo 1015 c.c., con responsabilità verso il nudo proprietario.
Nel contesto del fitto d’azienda, le parti possono decidere di “importare” questa disciplina. È una scelta contrattuale: se nel contratto si richiama espressamente l’articolo 2561 c.c., l’affittuario assume obblighi simili a quelli dell’usufruttuario.
Ed è proprio questa scelta che, per riflesso, attiva il regime di deduzione ammortamenti affitto d’azienda in capo al locatario.
Deduzione ammortamenti affitto d’azienda: la regola generale dell’articolo 102 TUIR
Se il contratto di affitto d’azienda richiama l’articolo 2561 c.c., entra in gioco l’articolo 102, comma 8, TUIR. Questo stabilisce che:
- le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito dell’affittuario
- il calcolo avviene sul costo originario dei beni, come risulta dalla contabilità del concedente
- le quote sono deducibili fino alla concorrenza del costo non ancora ammortizzato
In sostanza, l’affittuario “eredita” il piano di ammortamento del concedente, ma non il costo civilistico. Utilizza, però, quei valori come base per la deduzione fiscale.
Si crea così un doppio binario operativo:
- civilisticamente, i beni restano di proprietà del locatore;
- fiscalmente, l’affittuario deduce le quote di ammortamento come se li utilizzasse stabilmente nell’impresa.
Registro beni ammortizzabili e semplificazioni operative
Per poter dedurre legittimamente gli ammortamenti, l’affittuario deve tenere un proprio registro dei beni ammortizzabili, nel quale riportare i valori contabili del dante causa.
La norma consente alcune semplificazioni:
- per le imprese in contabilità ordinaria, le annotazioni possono confluire nel libro inventari;
- per le imprese in contabilità semplificata, possono essere inserite nel registro IVA acquisti.
Se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, o un altro libro idoneo ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 435/2001 e dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 695/1996, si applica una presunzione: si considerano già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso.
Questo significa che l’affittuario non può “ripartire da zero” ma deve scontare il fatto che metà delle quote precedenti si presumono già fiscalmente dedotte.
Beni immateriali: il richiamo agli articoli 103 e 108 TUIR
La logica non riguarda solo i beni materiali. L’ultimo comma dell’articolo 103 TUIR richiama, infatti, l’articolo 108, estendendo la disciplina anche ai beni immateriali: marchi, diritti di brevetto, eventuali avviamenti iscritti secondo corretti criteri contabili.
In pratica, nel perimetro della deduzione ammortamenti affitto d’azienda rientrano, in presenza dei presupposti, anche i cespiti immateriali, sempre secondo i valori e la residua vita utile desumibili dalla contabilità del locatore.
Quando il contratto deroga all’articolo 2561 c.c.
Non sempre, però, le parti vogliono attribuire all’affittuario l’onere di mantenere in efficienza l’azienda. Può accadere che il contratto preveda il contrario:
- è il locatore a impegnarsi a mantenere in efficienza l’azienda;
- l’affittuario paga il canone e utilizza il complesso, ma senza assumersi gli obblighi tipici dell’usufruttuario.
In questo scenario, si considera derogata la disciplina dell’articolo 2561 c.c.
La conseguenza fiscale è netta: l’articolo 102, comma 8, TUIR non si applica. Le quote di ammortamento restano in capo al locatore, che continua a dedurle nel proprio reddito d’impresa, a condizione che mantenga lo status di imprenditore.
Qui la scelta redazionale della clausola cambia totalmente la partita.
Tabella di sintesi: chi deduce gli ammortamenti
Per rendere più chiaro il quadro, si può schematizzare così:
| Situazione contrattuale | Obbligo manutenzione efficienza | Soggetto che deduce ammortamenti | Norma TUIR prevalente |
|---|---|---|---|
| Richiamo espresso art. 2561 c.c. | In capo all’affittuario | Affittuario | Art. 102, comma 8, TUIR |
| Deroga a art. 2561 c.c., obbligo in capo al locatore | In capo al locatore | Locatore (se imprenditore) | Regime ordinario del locatore |
| Affitto unica azienda di imprenditore che cessa | Nessun obbligo imprenditoriale | Nessuno (solo su futura plusvalenza) | Art. 67 TUIR, redditi diversi |
Perdita della qualifica di imprenditore e passaggio ai redditi diversi
C’è un ulteriore passaggio delicato. Può succedere che un imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui dispone.
In questa ipotesi, se la gestione imprenditoriale viene meno, il soggetto smette di essere imprenditore. Il reddito derivante dal canone non viene più qualificato come reddito d’impresa, ma come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. h), TUIR.
Quando il reddito assume questa natura, la deduzione delle quote di ammortamento non è più possibile. Il deperimento dei beni dell’azienda affittata si riflette solo in un secondo momento, se e quando l’azienda verrà ceduta:
-
il minor valore dei beni, rispetto al costo storico, ridurrà la plusvalenza imponibile in sede di cessione.
In altre parole, nel periodo di affitto non c’è deduzione; l’effetto fiscale del logorio economico si concentra in un unico momento futuro.
Effetti pratici: il deperimento dei beni senza deduzione
Se ci si trova nel caso appena descritto – affitto dell’unica azienda, perdita della qualifica di imprenditore – il locatore non può imputare a conto economico, ai fini fiscali, alcuna quota di ammortamento.
Il logorio dei beni resta un fenomeno solo economico e patrimoniale, destinato a emergere quando l’azienda verrà ceduta o dismessa.
In quella sede, il valore effettivo dei beni, se inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, ridurrà la plusvalenza o, in casi estremi, potrà generare una minusvalenza.
Per chi struttura operazioni di affitto d’azienda come forma di “gestione passiva” dell’unica azienda posseduta, questo punto è spesso sottovalutato. Tuttavia, sul piano fiscale, può spostare molto.
Clausole contrattuali e pianificazione fiscale: cosa guardare subito
Chi redige o analizza un contratto di affitto d’azienda dovrebbe chiedersi, subito, almeno tre cose:
I. Il contratto richiama espressamente l’articolo 2561 c.c.?
Se sì, la deduzione degli ammortamenti tende a spostarsi sull’affittuario, in base all’art. 102, comma 8, TUIR.
II. Chi è gravato dall’obbligo di mantenere l’azienda in efficienza?
Se è il locatore, la disciplina dell’usufrutto di azienda è, di fatto, derogata. Le quote restano in capo al concedente, a condizione che questi resti imprenditore.
III. Il concedente mantiene un’attività d’impresa rilevante?
Se affitta l’unica azienda e si limita a incassare il canone, si rischia il passaggio ai redditi diversi. In questo caso, non si deducono più ammortamenti durante l’affitto.
Nella prassi, spesso il contratto nasce con finalità civilistiche o di equilibrio economico tra le parti, e solo dopo si analizzano gli effetti fiscali. In realtà, per evitare sorprese, bisognerebbe ragionare al contrario.