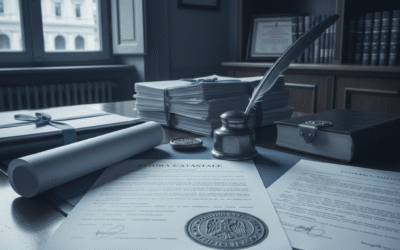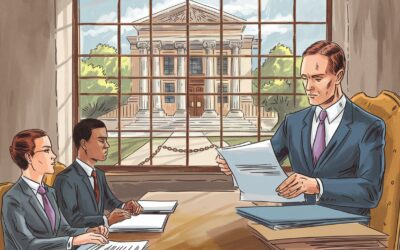Quando si affronta il delicato tema della successione familiare, il trust emerge come soluzione privilegiata fra i vari strumenti disponibili. Non si tratta di una valutazione casuale: chi opera nel settore riconosce questa efficacia sulla base di due fondamenti molto concreti, su cui conviene approfondire per comprendere davvero come funziona questo meccanismo e perché risulta tanto vantaggioso rispetto alle alternative tradizionali del nostro ordinamento.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Segregazione patrimoniale: Nel trust, i beni vengono trasferiti al trustee e rimangono separati dal suo patrimonio personale. Protezione da creditori terzi e aggredibilità limitata.
- Flessibilità gestionale: Il trustee amministra secondo l’atto istitutivo ma con ampia discrezionalità. Può adattarsi a situazioni non prevedibili nel tempo, anche dopo la morte del disponente.
- Confronto con fondo patrimoniale: Il fondo si esaurisce alla morte di un coniuge e diventa ingombrante per aziende/partecipazioni (ordinaria congiunta, straordinaria disgiunta). Il trust no.
- Vincoli di destinazione (art. 2645-ter): Offrono protezione ma gestione complicata post mortem e interpretazioni incerte delle intenzioni originarie.
- Durata plurigenerazionale: A differenza del patto di famiglia, il trust può protrarsi oltre la vita del disponente, garantendo protezione e governo del patrimonio per decenni.
- Azione revocatoria: Il trustee gode di argomenti solidi di difesa: il trasferimento risponde a scopi legittimi (tutela familiare), non a frode verso creditori.
1
La segregazione patrimoniale nel trust
La prima ragione per cui il trust passaggio generazionale rappresenta una soluzione tanto diffusa riguarda propriamente la protezione dei beni. Un genitore che desideri trasmettere ricchezza ai figli auspica, naturalmente, che quel patrimonio rimanga integro e non venga disperso per colpa di debiti, controversie o creditori dei beneficiari. Ecco dove interviene un aspetto cruciale: quando i beni finiscono in trust, avviene un trasferimento vero e proprio. Il disponente (chi crea il trust) cessa di esserne proprietario nel senso ordinario del termine; i beni diventano invece patrimonio del trustee, ma – e qui sta il punto decisivo – non come un proprietario comune. Il trustee gestisce, amministra, dispone secondo le regole scritte nell’atto costitutivo, eppure i beni rimangono segregati, cioè separati dal suo patrimonio personale. Se il trustee dovesse trovarsi in difficoltà economiche o affrontare controversie legali, quei beni restano protetti: i creditori non possono agire su di essi perché non appartengono al patrimonio aggredibile.
Naturalmente, un simile scopo di protezione non è esclusiva del trust. Nell’ordinamento italiano esistono altri istituti che offrono garanzie analoghe. Il fondo patrimoniale, ad esempio, rappresenta uno strumento celebre proprio per questa funzione protettiva. In esso i coniugi segregano una quota di beni, sottraendoli alle aggressioni di terzi. Tuttavia, il fondo patrimoniale possiede un limite strutturale: si estingue, per così dire, con la morte di uno dei due coniugi. Non è concepito per durare nel tempo né per governare successioni plurigenerazionali. Inoltre, quando si parla di aziende o partecipazioni societarie, il fondo patrimoniale diventa ingombrante: solo l’ordinaria amministrazione spetta congiuntamente ai coniugi in modo disgiunto (cioè ognuno può decidere da solo), mentre ogni decisione straordinaria richiede il consenso di entrambi. Questo meccanismo, benché protettivo, crea frequentemente situazioni di stallo.
Un ulteriore istituto domestico, i vincoli di destinazione previsti dall’articolo 2645-ter del codice civile, offre certamente margini di manovra più ampi. Consente di legare un bene a uno scopo particolare, garantendo che segua quella finalità nel tempo. Ma anche qui emerge un limite pratico: dopo la morte di chi ha istituito il vincolo, la gestione diviene complicata, con problemi di interpretazione delle intenzioni originarie e incertezze circa come proseguire.
Quanto al contratto di affidamento fiduciario – uno strumento più tradizionale – la segregazione del patrimonio si configura come questione enormemente problematica. Manca una norma espressa che la regoli. Potrebbe, teoricamente, derivare dalla possibilità di creare segregazioni in deroga all’articolo 2740 del codice civile (il quale stabilisce il principio secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio). Ma su questa strada si scontra una questione di fondo: taluni giuristi ritengono che l’articolo 2740 incarni una norma di ordine pubblico, non aggirabile. Dunque, la certezza di una vera segregazione rimane incerta, precaria.
Il patto di famiglia si colloca in una posizione ancora differente. Mediante questo strumento, l’imprenditore trasferisce al figlio l’azienda o partecipazioni societarie. La proprietà muta di titolare, passa da genitore a figlio, ma rest in capo a qualcuno. Non c’è davvero protezione nel senso che il patrimonio trasferito potrebbe comunque divenire esposto ai creditori del figlio. Ricorre il vecchio detto napoletano: “tre sono i potenti in terra, il papa, il re e chi non possiede nulla”. La proprietà, in altri termini, rimane sempre vulnerabile a meno che non sia, appunto, segregata.
La flessibilità come valore strategico
Il secondo fattore che rende il trust così apprezzato attiene piuttosto alla sua adattabilità nel tempo. Un meccanismo di trasmissione patrimoniale dovrebbe possedere la capacità di evolversi al mutar delle circostanze, di rispondere a situazioni che nessuno aveva previsto al momento della costituzione. Il trust eccelle proprio su questo terreno, offrendo quella che potremmo definire una soluzione particolarmente efficiente.
Quando il disponente decide di collocare beni in trust, cede al trustee il compito di amministrarli e di farli fruttare secondo le linee guida contenute nell’atto istitutivo. Ma qui risiede la vera flessibilità: il trustee non agisce come un semplice esecutore automatico di disposizioni rigide. Piuttosto, esercita valutazioni critiche, adatta scelte operative alle vicende che emergono, anche quando il disponente si trovi in una condizione di debolezza – per malattia, per avanzata età, per altre ragioni che rendano la sua interazione con il patrimonio difficile o impossibile. Allo stesso tempo, occorre vigilare attentamente al rispetto della quota di legittima dovuta ai familiari. Con questi accorgimenti, il trust può protrarsi ben oltre la morte del disponente, garantendo continuità nelle strategie familiari.
Immaginiamo uno scenario concreto: una famiglia possiede una piccola impresa di trasformazione alimentare, ricevuta da generazioni. Il padre, ormai anziano, desidera che il controllo della società vada al figlio maggiore, che ha dimostrato competenza gestionale e passione per il settore. Gli altri due figli, invece, hanno scelto carriere diverse e non hanno interesse a proseguire. Tramite trust, il trustee (magari con supporto di advisor esterni) avrà la libertà di valutare nel tempo quale sia il modo migliore di procedere: trasferire le quote al figlio più idoneo, proteggendo gli altri con risorse diverse, oppure, qualora nessuno desiderasse continuare, alienare l’azienda e usare il ricavo per mantenere e assistere tutti i beneficiari secondo necessità. Questa elasticità è rara negli altri strumenti: il patto di famiglia richiede contrattazione fra le parti, il fondo patrimoniale non si adatta, il vincolo di destinazione rimane cristallizzato nell’intenzione originaria.
Confronto operativo con gli alternative ordinarie
Osservando il quadro normativo italiano, la segregazione rimane, sostanzialmente, assente negli istituti di trasmissione ordinaria come il patto di famiglia. Partecipazioni e aziende si trasferiscono dal genitore al figlio; la proprietà cambia titolare, ma continua a essere concentrata in una persona fisica e quindi potenzialmente esposta ai creditori.
Il fondo patrimoniale, sebbene garantisca segregazione, non rappresenta affatto uno strumento di ricambio generazionale nel vero senso. Si consuma, si esaurisce alla morte di uno dei coniugi. Per le partecipazioni societarie, inoltre, crea situazioni farraginose: l’ordinaria amministrazione spetta ai due coniugi in modo disgiunto (ognuno decide per conto proprio), mentre l’amministrazione straordinaria (operazioni complesse come aumento di capitale, cessione di quote, fusioni) richiede il consenso congiunto. Questo genera frequentemente blocchi decisionali quando i coniugi non concordano.
Il vincolo di destinazione, disciplinato dall’articolo 2645-ter, possiede qualche risorsa in più. Però la gestione dei beni vincolati diventa effettivamente complicata dopo la scomparsa del disponente. Sorge incertezza su come interpretare le intenzioni espresse nel vincolo medesimo, su chi eserciti le facoltà amministrative, su come il patrimonio vincolato si collochi nel procedimento successorio.
Praticità e continuità nel tempo
Il trust passaggio generazionale offre, dunque, un equilibrio fra protezione e adattabilità che gli altri istituti faticano a raggiungere. Il patrimonio rimane segregato, protetto da aggressioni esterne. Al contempo, il trustee mantiene la capacità di gestire le risorse in funzione di realtà che si muovono e cambiano.
Inoltre, il trust consente di affrontare situazioni che la successione ordinaria non gestisce fluidamente. Un genitore potrebbe temere che un figlio, benché amato, non abbia la maturità finanziaria per ricevere direttamente una ingente somma di denaro, oppure potrebbe desiderare di sostenere i beneficiari nel tempo senza consegnare capitali una volta per tutte. Attraverso il trust, il trustee distribuisce i frutti dei beni secondo tempistiche e criteri dettati dall’atto, garantendo che il supporto prosegua nel modo voluto dal disponente anche dopo la sua morte.
La questione dei creditori merita ulteriore considerazione. Nell’azione revocatoria, uno strumento mediante il quale i creditori del disponente possono cercare di aggredire beni trasferiti di recente, il trust possiede solidi argomenti di difesa. Il trasferimento al trustee avviene perché il disponente intende realizzare uno scopo specifico (tutela familiare, protezione patrimoniale), non per sottrarre beni ai propri creditori. Questo distingue il trust dalla vera e propria frode ai danni dei creditori.
Ultimo aspetto, ma non meno rilevante: la durata del trust si estende oltre la vita del disponente. A differenza del fondo patrimoniale o del patto di famiglia – che si concentrano principalmente sulla generazione presente – il trust può costituire una struttura di governo del patrimonio per decenni, attraversando più generazioni. Un nonno può istituire un trust che protegga la ricchezza di figli e nipoti, gestito da un trustee indipendente che garantisca il perseguimento della finalità originaria.