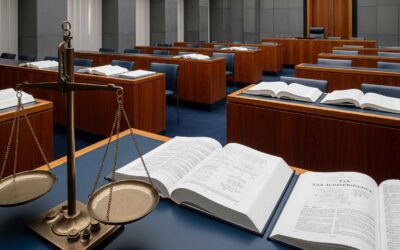Con l’ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025, il Tribunale di Bari ha affrontato una questione interpretativa di primaria rilevanza circa l’applicabilità temporale del novellato art. 2407 c.c., come modificato dalla L. 35/2025, stabilendo che i nuovi parametri limitativi della responsabilità dei componenti del collegio sindacale trovano applicazione anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma, avvenuta il 12 aprile 2025.
Il contesto processuale e la fattispecie concreta
La pronuncia si colloca nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa dal curatore di una società in liquidazione giudiziale nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 CCII e 2394 c.c.
La fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale presenta elementi di particolare complessità: il curatore ha eccepito la completa erosione del capitale sociale, formalmente emergente dal bilancio d’esercizio 2021, ma sostanzialmente riconducibile già all’esercizio 2017, il cui bilancio risultava approvato nei primi mesi del 2019. In relazione a tale bilancio, i revisori legali avevano espresso un’impossibilità di giudizio (“disclaimer of opinion”) ex art. 14, comma 2, lett. d), D.Lgs. 39/2010, evidenziando molteplici e rilevanti incertezze circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.
Nonostante tale quadro di manifesta crisi, gli organi amministrativi procedevano alla restituzione di ingenti finanziamenti a favore di soggetti qualificabili come parti correlate, segnatamente le mogli di ex soci. Tale condotta è stata qualificata dal Tribunale come integrazione degli estremi del pagamento preferenziale, in violazione del principio della par condicio creditorum, con conseguente danno per la massa dei creditori sociali.
L’interpretazione della portata temporale dell’art. 2407 c.c. novellato
Il Tribunale ha dovuto confrontarsi con l’assenza di una disposizione transitoria esplicita nella L. 35/2025 relativamente all’applicazione dei nuovi limiti di responsabilità dei sindaci. La soluzione interpretativa adottata si fonda sulla qualificazione della norma come disposizione “lato sensu procedimentale”, in quanto essa si limiterebbe a fornire al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza incidere sulla sussistenza del diritto sostanziale al risarcimento.
Tale interpretazione trova conforto in recente giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cass. civ., Sez. I, nn. 5252/2024 e 8069/2024, che, in tema di calcolo equitativo del danno ex art. 2486 c.c., ha affermato l’applicabilità retroattiva delle norme concernenti la mera quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale ha specificatamente distinto la natura della disposizione in esame da quella relativa alla decorrenza della prescrizione, quest’ultima pacificamente qualificata come norma di carattere sostanziale e, pertanto, non suscettibile di applicazione retroattiva ex art. 11 disp. prel. c.c.
La portata applicativa del nuovo limite risarcitorio
L’ordinanza sviluppa un’interpretazione sistematica del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., stabilendo che il tetto massimo di responsabilità, parametrato a multipli del compenso annuo percepito, vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dalla violazione dei doveri sindacali.
Tale lettura si fonda sull’esegesi letterale della disposizione, che collega la responsabilità dei sindaci “per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori ed ai terzi” alla violazione dei propri doveri, evidenziando la necessità di un nesso causale specifico tra ciascuna violazione e il relativo danno.
Il Tribunale ha precisato che non si tratta di un’esimente della responsabilità sindacale, bensì di una limitazione quantitativa della stessa, operante in relazione al danno conseguente alla condotta colposa o dolosa.
La determinazione del compenso annuo rilevante
Nell’affrontare la questione della base di calcolo per l’applicazione del moltiplicatore, il Tribunale ha aderito all’orientamento dottrinale prevalente, interpretando il “compenso annuo percepito” come il compenso effettivamente riconosciuto al sindaco, corrispondente all’importo netto deliberato dall’assemblea ex art. 2402 c.c.
La motivazione evidenzia come un’interpretazione diversa condurrebbe al paradosso per cui la norma limitativa della responsabilità patrimoniale risulterebbe inapplicabile nei casi di inadempimento della società nei confronti del sindaco medesimo.
L’applicazione al caso concreto: la distinzione tra danni
Nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto a un’articolata ricostruzione dei profili di responsabilità, individuando due distinte tipologie di danno:
- Il danno generico: derivante dalla prosecuzione dell’attività sociale in presenza di perdita integrale del capitale, in violazione dell’obbligo di vigilanza ex art. 2403 c.c.;
- Il danno ulteriore da mala gestio: conseguente all’omessa vigilanza sulla restituzione dei finanziamenti, qualificata come atto dispositivo preferenziale in pregiudizio della par condicio creditorum.
Per ciascuna tipologia di danno, il Tribunale ha applicato il limite massimo previsto dal novellato art. 2407, comma 2, c.c., computando separatamente i tetti risarcitori.
Profili di criticità e questioni aperte
La pronuncia solleva interrogativi di non secondaria importanza circa la compatibilità dell’interpretazione adottata con i principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo. L’inquadramento della disposizione come norma procedimentale, seppur supportato da autorevoli precedenti di legittimità, potrebbe non essere del tutto pacifico, considerata la natura sostanziale del diritto al risarcimento del danno.
Ulteriori profili di riflessione riguardano:
- La possibile disarmonia sistematica derivante dall’applicazione retroattiva di una norma che incide significativamente sull’assetto delle responsabilità nell’ambito della governance societaria;
- L’impatto sul contenzioso pendente e sulle strategie processuali delle parti;
- La necessità di un intervento chiarificatore del legislatore o della Suprema Corte.
Prospettive evolutive e considerazioni de iure condendo
La pronuncia si inserisce in un più ampio processo di riforma del diritto societario, orientato verso un bilanciamento tra responsabilizzazione degli organi di controllo e proporzionalità delle sanzioni. L’approccio adottato dal Tribunale di Bari potrebbe costituire un precedente significativo nell’interpretazione delle norme transitorie in materia societaria.
Rimane aperta la questione se tale orientamento troverà conferma in sede di legittimità o se, al contrario, prevarrà un’interpretazione più restrittiva, ancorata al principio di irretroattività della legge sostanziale.
Riflessioni conclusive
L’ordinanza n. 1981/2025 del Tribunale di Bari rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione interpretativa del nuovo regime di responsabilità sindacale. La scelta di privilegiare una lettura procedimentale della norma, con conseguente applicabilità retroattiva, riflette un’esigenza di certezza del diritto e di uniformità applicativa nel contesto delle riforme societarie.
L’approccio casistico adottato, che distingue tra diverse tipologie di danno e correla il tetto massimo a ciascun evento lesivo, fornisce indicazioni operative precise per gli operatori del diritto, pur lasciando aperti margini di incertezza che richiederanno ulteriori interventi chiarificatori, giurisprudenziali o legislativi.