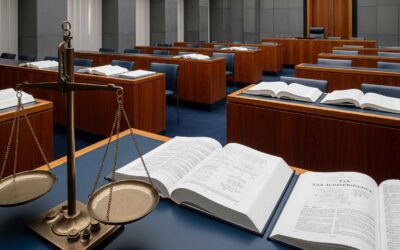La Corte di Cassazione torna a tracciare i confini della responsabilità penale dei sindaci nei casi di fallimento societario. Con la sentenza n. 32560 depositata il 2 ottobre 2025, la Quinta Sezione penale affronta un tema delicato: quando l’organo di controllo può essere chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta per non aver vigilato sull’operato degli amministratori?
La vicenda sottoposta ai giudici di legittimità riguarda un presidente di collegio sindacale accusato (e poi condannato) per aver consentito agli amministratori di una srl di provocare il dissesto. Le condotte contestate agli amministratori erano particolarmente gravi. Crediti inesistenti per circa otto milioni di euro appostati in bilancio, denaro sottratto dalle casse sociali senza alcuna giustificazione, scritture contabili falsificate al punto da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale.
Il collegio difensivo del sindaco aveva sostenuto l’assenza di responsabilità penale. Secondo la difesa, si trattava di una mera negligenza nell’espletamento dei controlli, non di un concorso doloso nel reato fallimentare. Ma la Suprema Corte ha confermato la condanna.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La responsabilità penale dei sindaci nelle società scatta se omettono controlli su segnali d’allarme evidenti in bilancio o nella contabilità.
- Non basta la negligenza, occorre dolo: consapevole accettazione del rischio che l’omissione favorisca condotte illecite degli amministratori.
- I sindaci hanno obbligo di attivarsi tempestivamente e denunciare gravi irregolarità: la semplice forma non salva dal reato se la sostanza è falsa.
- La recente sentenza Cass. 32560/2025 ribadisce: l’inerzia dolosa può portare a condanna per concorso in bancarotta.
- Chi svolge funzioni di controllo deve saper cogliere e agire su ogni anomalia, pena gravi rischi penali e professionali.
Quando scatta la responsabilità penale del collegio sindacale
Chi riveste la carica di sindaco (o componente del collegio) assume una posizione di garanzia rispetto alla corretta gestione societaria. Questo significa che può rispondere penalmente anche per condotte omissive, secondo quanto previsto dall’art. 40 cpv. cod. pen. Non basta verificare la regolarità formale dei documenti contabili – occorre un controllo sostanziale sulla congruità tra quanto risulta dai libri sociali e la realtà operativa dell’impresa.
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che il concorso in bancarotta fraudolenta può configurarsi pure nei confronti dei sindaci che abbiano omesso i dovuti controlli. Esiste infatti il potere di segnalazione previsto dall’articolo 2409 c.c., norma che disciplina i poteri dell’organo di controllo. Più recentemente, l’art. 2403-bis c.c. ha rafforzato tale obbligo, conferendo ai sindaci il potere-dovere di richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni aziendali.
Nella prassi professionale, però, non è sufficiente dimostrare che il sindaco non ha vigilato. Serve qualcosa in più.
I “segnali d’allarme” come presupposto della condanna
Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio questo aspetto: quando la condotta contestata consiste nell’omesso controllo, bisogna verificare che nella contabilità sociale fossero già presenti elementi rivelatori delle irregolarità. La Cassazione parla di “segnali d’allarme” oppure “indici rivelatori” delle condotte illecite perpetrate dagli amministratori.
Solo in presenza di tali elementi si può affermare che l’omissione era colpevole (e non meramente colposa) e che ha concretamente agevolato le condotte distrattive o fraudolente. Questo principio è del tutto analogo a quanto la giurisprudenza penale afferma in relazione agli amministratori privi di delega (si veda, tra le molte, Cass. n. 33582/2022).
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 32560/2025, i giudici hanno ritenuto che i segnali fossero non solo presenti, ma addirittura palesi. Vediamo quali.
Gli elementi sintomatici individuati nel caso concreto
I bilanci della società presentavano attivi viziati dall’appostazione di crediti ingenti nei confronti di alcune imprese cubane. La loro veridicità appariva palesemente dubbia, mancava qualsiasi titolo contrattuale sottostante. Si trattava di poste decisive per l’equilibrio finanziario dell’azienda (stiamo parlando di milioni di euro, non di importi trascurabili).
La contabilizzazione di tali crediti aveva permesso agli amministratori di proseguire l’attività societaria, prelevando nel frattempo somme considerevoli – anche queste senza alcun titolo giustificativo – versandole a se stessi o a società riconducibili alla loro sfera personale. E qui emerge un altro aspetto: nessun tentativo di recupero dei presunti crediti era mai stato effettuato, il che avrebbe dovuto insospettire qualunque organo di controllo minimamente diligente.
Secondo la Corte, le condotte degli amministratori erano così evidenti che i sindaci le avrebbero certamente dovute rilevare dalla medesima contabilità (e dal controllo degli atti sottostanti). La totale inerzia del collegio sindacale aveva reso possibile il perpetrarsi delle distrazioni.
Proviamo a ragionare con un esempio. Immaginiamo una società che opera nel settore commerciale con un fatturato annuo di tre milioni. In bilancio compare un credito di due milioni verso un’azienda estera, senza contratto, senza fatture di vendita, senza corrispondenza commerciale. Nel frattempo, il conto corrente sociale registra bonifici costanti agli amministratori per “compensi” o “prestiti” mai deliberati dall’assemblea. Un sindaco diligente potrebbe non accorgersene? Difficile sostenerlo.
La natura dolosa dell’omissione
Ma c’è un altro passaggio fondamentale nella motivazione. La responsabilità sindaci bancarotta non può fondarsi su semplice negligenza, per quanto grave. I giudici hanno distinto chiaramente il piano civilistico (dove la colpa può bastare per la responsabilità risarcitoria) dal piano penale, che richiede il dolo.
La sentenza richiama espressamente il concetto di dolo eventuale: occorre dimostrare che il sindaco, pur non avendo un accordo preventivo con gli amministratori, abbia consapevolmente omesso i controlli accettando il rischio che tale omissione favorisse le condotte illecite. La durata dell’inerzia, il numero e la gravità delle irregolarità, il contesto complessivo di illegalità possono costituire indici rivelatori della volontà dolosa.
Nel procedimento in esame, il presidente del collegio sindacale aveva mantenuto la carica durante tutto il periodo in cui si consumavano le operazioni fraudolente. Non si trattava di una singola svista, ma di un’omissione prolungata nel tempo, a fronte di anomalie macroscopiche.
L’obbligo di vigilanza oltre il controllo contabile
Ai sensi dell’articolo 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Questa vigilanza non può limitarsi alla verifica formale delle scritture.
Come spesso accade nella casistica pratica, le irregolarità più gravi si annidano proprio nel rapporto tra rappresentazione contabile e realtà sottostante. Un bilancio può essere formalmente corretto (partita doppia rispettata, scritture regolari) ma sostanzialmente falso se i valori iscritti non corrispondono a fatti realmente accaduti.
L’art. 2403-bis c.c. attribuisce ai sindaci il potere di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Si tratta di un potere che diventa dovere quando emergono elementi di criticità. L’organo di controllo deve attivarsi, porre domande, richiedere documentazione.
Differenze con la responsabilità degli amministratori non operativi
Il ragionamento della Cassazione appare coerente con l’orientamento consolidato in materia di amministratori privi di delega. Anche costoro possono rispondere di bancarotta per omesso impedimento dell’evento, ma solo se erano presenti “campanelli d’allarme” che avrebbero dovuto indurli a intervenire.
La giurisprudenza richiede dunque un accertamento concreto, non automatismi basati sulla mera qualifica formale. Non si risponde penalmente solo perché si ricopre una certa carica (amministratore o sindaco che sia), ma perché in presenza di segnali evidenti non si è fatto nulla per impedire il danno ai creditori.
Questo approccio tutela i professionisti che svolgono con diligenza i propri compiti, mentre colpisce chi rimane inerte davanti a situazioni palesemente irregolari.
Quali poteri ha (e deve esercitare) il sindaco
Secondo quanto previsto dall’articolo 2409 c.c., quando i sindaci riscontrano gravi irregolarità nella gestione, devono riferirne all’assemblea. Se questa non adotta provvedimenti o se le irregolarità persistono, si deve fare denuncia al tribunale. È una procedura graduale ma vincolante.
Nella pratica professionale si osserva talvolta una certa riluttanza nell’attivare tali meccanismi, per timore di danneggiare i rapporti con gli amministratori o con la compagine sociale. Ma il ruolo del sindaco è proprio quello di garantire la legalità, anche a costo di creare tensioni.
La normativa prevede inoltre altri strumenti: la convocazione dell’assemblea (art. 2406 c.c.) se gli amministratori omettono di farlo, la possibilità di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, il diritto di ispezionare i libri sociali. Tutti poteri che restano sulla carta se non vengono concretamente esercitati.
Riflessioni sulla posizione del collegio sindacale
La sentenza 32560/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. La responsabilità penale del sindaco per concorso in bancarotta richiede tre elementi: a) l’omesso doloso esercizio dei doveri di controllo; b) il nesso causale tra tale omissione e le fattispecie di bancarotta (oggi disciplinate dall’art. 322 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019, che ha sostituito l’art. 223 della vecchia legge fallimentare); c) il dolo riferito alla condotta degli amministratori.
Non bastano pertanto generiche affermazioni sulla mancata vigilanza. Occorre dimostrare che il sindaco, pur potendo e dovendo intervenire, non lo ha fatto con la consapevolezza (o l’accettazione del rischio) che ciò avrebbe facilitato le condotte distrattive o fraudolente.
I giudici di merito devono quindi motivare adeguatamente su tutti questi aspetti. Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva evidenziato come a fronte della grave situazione di squilibrio finanziario, il collegio sindacale non avesse adottato alcuna vigilanza stringente né posto in mora gli amministratori su operazioni singole ma rilevantissime. Controlli tempestivi avrebbero potuto evitare o almeno attenuare l’evento distrattivo.
Conseguenze pratiche per i professionisti
Chi svolge funzioni di controllo nelle società deve essere consapevole dei rischi penali connessi all’inerzia. Non si tratta di svolgere un ruolo meramente formale, approvando bilanci già predisposti dagli amministratori senza verificarne la sostanza.
Le domande da porsi sono concrete: i crediti iscritti in bilancio corrispondono a fatture emesse? Esistono contratti sottostanti? Sono stati effettuati tentativi di riscossione? I debiti tributari e previdenziali vengono pagati regolarmente? Le operazioni straordinarie (conferimenti, finanziamenti, cessioni) hanno una causa giustificativa?
Come talvolta si verifica nella prassi, piccole anomalie apparentemente trascurabili possono nascondere situazioni ben più gravi. Il ruolo del sindaco è appunto quello di cogliere questi segnali prima che sia troppo trop tardi.